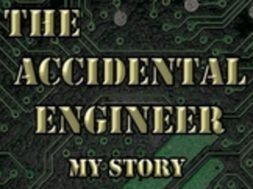(Di Carlo Di Stanislao)
“The Zero Theorem”, ultima fatica di Terry Gilliam, delude parecchio critica e pubblico, come anche “Parkland” di Peter Landesmas, mentre piace “Ana Arabia” di Amos Gitai: un unico piano sequenza in formato 1:25, che racconta un momento nella vita di una piccola comunità di reietti, ebrei e arabi, che vivono insieme in un angolo dimenticato da tutti, al “confine” fra Jaffa e Bat Yam, in Israele.
In corsa per il Leone D’Oro, il distopico Gilliam in ‘The zero theorem’ racconta di Qohen Leth (interpretato dalla Palma d’Oro e Oscar, Christopher Waltz) , un geek a cui la multinazionale per cui lavora affida il compito di risolvere un rompicapo algebrico/informatico per smettere di subire perdite economiche.
Correggendo l’assunto di Marx Gillian prova a dirci che il vero oppio dei popoli è la tecnologia ed è il web il pericolo maggiore per la libertà individuale. Ma il film è confuso, con scenografie che esorbitano personaggi e racconto e una ispirazione stanca e lontana anni luce dai gloriosi giorni d’oro del regista di Minneapolis oramai inglese fin dai tempi dei Monthy Python.
Venezia si entusiasma, invece, grazie a “The lost child of Philomena Lee” di Martin Sixmith, con Stephen Frears e Judy Dench che è al Lido e nel film (applauditissimo) presta il volto ad una anziana signora irlandese rimasta incinta, adolescente, nel 1952 e che viene mandata nel convento di Roscrea, dove le suore aiutavano le ragazze “perdute” a partorire “nel dolore”, per espiare il proprio peccato…), salvo strappar poi loro i bambini per darli in adozione a famiglie facoltose, prevalentemente americane.
Basato su vicende realmente accadute e sostenuto da una sceneggiatura impeccabile e brillante – firmata anche da Frears e dal co-protagonista, il bravo Steve Coogan – il film è una storia di dolore e di ingiustizia, di fede e di rimpianto, di amore e di perdono, con il regista che torna a Venezia sette anni dopo “The Queen” e che ha predisposto tutto per fare il bis della Colpa Volpi che allora andò ad Helen Mirren ed ora potrebbe toccare alla Dench, che a 78 anni, ha vinto un Oscar per il ruolo della Regina Elisabetta I in “Shakespeare in Love” (1998) di John Madden, ma sarebbe quasi sconosciuta al grande pubblico se non fosse per i ruolo di M in ben tre degli ultimi film di James Bond: 007.
Interessante ed apprezzato “Transumanza”, corto in stretta lingua sarda di Salvatore Mereu, vincitore, nel 2004 del David di Donatello come miglior regista esordiente con il suo primo lungometraggio, “Ballo a tre passi”, vincitore anche della ‘Settimana della Critica’ alla Mostra del Cinema di Venezia, che alla Berlinale 2008 nella sezione ‘Panorama’ ha presentato il suo secondo film, “Sonetaula”, dall’omonimo libro di Giuseppe Fiori e l’anno scorso ha diretto il bellissimo “Bellas mariposas”, una delle cose migliori della passata stagione.
Banale e scontato, invece, il documentario di Alex Gibney “The Armstrong Lie”, sulla vita e le vicissitudini del celebre ciclista, con lo stesso protagonista performativo davanti alla macchina da presa e in mezzo, le testimonianze dirette dei grandi accusatori (il giornalista scozzese David Walsh, il ciclista Filippo Simeoni) e dei grandi complici (Bruynel e il medico Ferrari).
Pollice recto per “Locke” di Steven Knight, con Tom Hardy che fa centro e ieri, fuori concorso, riceve applausi, convince la critica e va di diritto tra le rare sorprese di un festival fiacco.
Si tratta è l’opera seconda di Steven Knight e potrebbe sintetizzarsi come ‘dramma da auto’, anzichè dramma da camera: per 84 minuti vediamo solo il protagonista – l’attore emergente inglese Tom Hardy, visto tra l’altro in Batman- che guida e parla al telefono. Nell’ordine: con casa, prima con uno dei figli che sta seguendo in tv una partita e lo aspetta per cenare con birra e salsicce, poi con la moglie Katrina che ha appena scoperto di essere tradita. Poi con Bethan, il sesso di una notte, quanto basta per restare incinta e chiedergli di essere presente al parto. Poi il lavoro: Ivan Locke dovrebbe seguire l’organizzazione di una colata storica di calcestruzzo, lo stesso che serve per gettare le fondamenta della nuova casa. Ma anche qui le cose non vanno come aveva organizzato.
Ieri di scena Scarlett Johansson, enigmatica e seducente aliena per “Under the skin”, di Jonathan Glazer, un film mediocre che vive solo della sua luce e “Harlock Space Pirate (3D)” di Aramaki Shinji, che anche delude In Orizzonti Uberto Pasolini (produttore di Full Monty) torna alla regia con “Still Life”, mentre Matteo Oleotto, unico italiano in gara alla Settimana della Critica ha presentato “Zoran. Il mio nipote scemo”, senza suscitare, in entrambi i casi, particolari entusiasmi.
Si attende ora, sempre fuori concorso “Moebius” di Kim Ki-Duk, che promette di sconvolgere il Festival, inizialmente bandito in Corea, il paese del regista, con lo stesso che è corso ai ripari rimuovendo 21 scene e modificandone altre per ottenere il visto della censura.
Il film ha lo stesso titolo (ma trama completamente diversa” di uno del 1996, realizzato dal Prof. Gustavo Mosquera, ispirato ad un racconto di un astronomo americano, A. J. Deutsch, la cui trama parla di un matematico, più precisamente un topologo, impegnato a risolvere il mistero della scomparsa di un treno della metropolitana.
Già acquistato a scatola chiusa da tantissimi paesi, tra cui Italia (Movies Inspired), Germania, Austria, Svizzera, Russia, Grecia e Turchia, siamo certi che il film di Ki-Duk farà discutere per la storia a che ruota attorno ad una famiglia che sta andando in frantumi, con la madre che ferisce per sbaglio il figlio a morte, mentre il marito, per espiare i suoi peccati sessuali, si auto-evira. Tutto ciò, ovviamente, mentre la famiglia cade in un baratro senza fine.
“Moebius” è interpretato da Jae-hyeon Jo, che ritrova Kim dopo 12 anni dalla loro ultima collaborazione (lo strepitoso “Bad Guy”), da Seo Young Ju (miglior attore al Tokyo International Film Festival per il suo ruolo in “Juvenile Offender”), e Lee Eunwoo. Il trailer su: http://www.stracinema.com/2013/08/moebius-teaser-trailer-e-prime-foto-il.html.
Kim Ki-duk ha trovato la sua massima fortuna nella prima metà degli anni 2000, periodo in cui è stato amato da un pubblico di giovani, così entusiasti che hanno voluto riscoprire anche i suoi lavori precedenti, ovviamente inediti in sala. Poi, ad un certo punto, la fortuna di Kim è iniziata a scemare, nel momento in cui le sue pellicole hanno cominciato a far discutere animatamente sotto il profilo artistico.
Prima fu L’arco, poi Time. Ci fu quindi un momento in cui Kim pareva essere ritornato ad essere quella figura centrale del cinema orientale per gli appassionati, grazie a Soffio. Infine è arrivato Dream: un’esperienza spaventosa, traumatica, che ha segnato il regista a causa di un incidente che ha coinvolto la protagonista del film. Da quel momento, Kim non è stato più lo stesso, ed ha passato un periodo di depressione fortissima, raccontata nel documentario Arirang. Kim ha girato in fretta e furia un nuovo lungometraggio, Amen, che avrebbe dovuto rimetterlo in carreggiata. Il risultato non lo ha convinto, tant’è che ha ritirato il film definitivamente.
Poi è arrivato “Pieta”, suo 18° film, che stupisce perché è furioso e allo stesso tempo delicato e straziante, curato nella forma e mai lasciato al caso, con citazioni continue dal grande cinema americano ed asiatico, ma tali da essere dispotiche ed originali, così come Le “Déjeuner sur l’herbe “e “l’Olympia”, visti di recente proprio a Venezia, in mostra dal 24 aprile al 18 agosto, a Palazzo Ducale, nella esposizione “Manet. Ritorno a Venezia”, sono chiaramente variazioni originali da Tiziano, ma con occhi e sensibilità completamente nuovi.
Come per tutti i grandi, quello di Kim è sempre stato un cinema di relazioni “oltre”, completamente fuori dagli schemi, in cui bastano una serie di sguardi o una canzone cantata al telefono per accendere la tenerezza in ambiti scomodi e difficili, inserita contesti complicati dal potere e dal denaro.
Siamo certi che anche quest’anno, lui almeno, non ci deluderà.
(46)