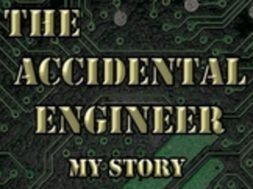(Di Carlo Di Stanislao) E’ stato fischiato in sala “L’intrepido” di Gianni Amelio, certo non un film eccelso, con vistose increspature nella sceneggiatura, ma certamente un film coraggioso su un tema la cui attualità è patentemente diuturna, come ci ricorda, dolorosamente, il suicidio di ieri di un giovane trentenne di Roseto degli Abruzzi, stanco di essere respinto dal mondo del lavoro, dopo una laurea magna cum laude.
Il film è certamente pieno di luoghi comuni e con un bozzzettismo in bilico fra la depressione e la sensibilità artistica, ma resta il merito di voler raccontare il ring dell’Italia di oggi: un paese che non lascia speranze, soprattutto ai giovani.
Molto bravo è Antonio Albanese, nei panni del protagonista Antonio Pane, che vive nel rispetto assoluto dell’etica del lavoro, conducendo una vita solitaria e cercando di vincere la tristezza e di rendere migliore la vita altrui. Lavoratore manuale cresciuto nel rispetto sacro per chi invece ha talento artistico (“tenere in mano un libro è sempre speciale”), sembra rappresentare il lavoratore ideale intorno a cui la nostra costituzione ha costruito il suo articolo 1, fondando la Repubblica sul lavoro, una maschera melanconica ed anzi angosciante, che si muove in una Milano spaesata che vuol rappresentare i nostri tempi, dove la crisi economica e occupazionale ha fatto superare il concetto di lavoratore precario arrivando al “rimpiazzo”: colui il quale sostituisce a ore i lavoratori. Così come in “Giorni e nuvole” il personaggio interpretato da Albanese ha perso il lavoro, e la vergogna gli impedisce di dirlo al figlio e all’ex moglie; di chiedere lui, per una volta, aiuto agli altri.
Rimanere disoccupati è un’esperienza traumatizzante che se non affrontata ed elaborata in modo corretto spinge l’individuo in un circolo vizioso di isolamento e perdita di speranza. Le conseguenze psicologiche producono un senso di colpa e di vergogna che minano la propria autostima e i rapporti con i familiari perché colpiscono soprattutto a livello dell’identità personale. Infatti, perdere il lavoro, oltre alle evidenti problematiche legate al dato economico, costituisce prima di tutto una minaccia per l’integrità dell’immagine di sé, perché è attraverso soprattutto la propria condizione lavorativa che l’identità di un individuo si costruisce e si afferma. In questa situazione angosciosa spesso la persona non riesce a trovare sollievo nel proprio ambiente familiare e sociale, si allontana sempre più in una alienazione di sé e dei propri desideri.
Tutto questo ne “L’intrepido” è a volte fumettistico o troppo virante al grottesco e tuttavia vanno riconosciuti al film alcuni meriti (oltre al tema affrontato e ad Albanese): la descrizione di una Milano finalmente senza navigli e più autentica (come quella di “Colpire al cuore”, del 1983, dello stesso regista) ed una fotografia (di Luca Bigazzi), davvero magnifica e meritevole di premio.
In fondo ha ragione Tati Sanguineti che su Iris ci dice che Amelio ha fatto sempre lo stesso film, a volte più riuscito di altre. Il mio preferito resta “Colpire al cuore”, raccontro ispirato tra memoria, orgoglio e una ferita ancora non del tutto cicatrizzata, di una intera generazione, significativamente unico film prodotto dalla RAI che non èfu seguito da nessuno funzionario quando fu presentato a Cannes.
Amelio, 68 anni, calabrese, vincitore di un Leone d’oro e di un David di Donatello per il miglior film, nomimato per svariati premi internazionali (Oscar al miglior film straniero, European Film Awards per il miglior film, Independent Spirit Award per il miglior film straniero), qui sembra aver realizzato qualcosa che ha sbagliato cittadinanza, affine com’è più all’universo letterario che a quello cinematografico, nel quale sembra calato con non poca fatica.
Il che stupisce, perché a dispetto di una regia poco incline a giochi pirotecnici, l’asciutto e diretto Amelio ha anche di recente dimostrato di non essersi smarrito chissà dove (qui il riferimento è al suo penultimo film di appena due anni fa, “Il primo uomo”).
In questo caso ci si limita invece a riportare certi cliché, come l’uomo di successo cinico che se esce con frasi patetiche del tipo “un uomo senza cravatta compra ma non vende“, o come il mal di vivere appenna abbozzato di certa gioventù; tutti elementi finiscono per travolgere un’idea davvero deliziosa di questo stoico lavoratore jolly che sgobba senza mai lamentarsene, come si addice ad un figlio del Sud.
Da oggi il film è nelle sale come anche forse il più brutto film del Festival dele “uova sode” (come ha detto l’arguto Sanguineti denunciandone l’ormai inarrestabile declino): “Child of God” di da James Franco, realizzato dopo “Interior.”, “Leather Bar” e “As I Lay Dying”, trasposizione del crudo Figlio di Dio di Cormac McCarthy, imperfetto, radicale, estremo nella costruzione e a tratti un po’ noioso, ma con uno Scott Haze da Coppa Volpi grazie alla sua interpretazione “bestiale”.
Il film (coraggioso ma ancor meno riuscito di quello di Amelio), fa coppia per bruttezza con l’altro americano in concorso “Parkland”, in cui Peter Landesmas parla dell’assassinio del Presidente Kennedy in quell’assolato giorno di Novembre a Dallas, un film scialbo e deludente in cui l’autore si limita a ricordarci che cinque decadi fa venne ucciso l’allora Presidente degli Stati Uniti d’America e di tutto il resto tace.
Parkland è il nome dell’ospedale in cui furono ricoverati sia il Presidente Kennedy che, successivamente, il suo assassino Oswald. Volendo in qualche modo trarre un’indicazione fornitaci dal film, sembra si faccia leva sulla complessità dell’intera faccenda nel suo aspetto meramente umano. Passando in rassegna, in maniera breve ed incerta, gli episodi che hanno coinvolto, tra gli altri, Abraham Zapruder (autore delle famose riprese relative al momento degli spari) e la famiglia di Oswald, con le reazioni di segno completamente opposto da parte della madre da un lato, e del fratello di colui che premette il grilletto dall’altro. Un modo come un altro per rimettere a fuoco le vere vittime di quell’evento così poco chiaro, vanificato però da un soggiorno sin troppo prolungato in superficie. Raffazzonato, privo di alcun mordente, Parkland, in altre parole, è un film che rischia a più e più riprese di risolversi in maniera sin troppo insipida.
Eccellente, invece, la lunga interbista attraverso il tempo a Bernardo Bertolucci realizzata da Luca Guadagnino e Walter Fasano, un ottimo e singolare montaggio di rari materiali su un autore che resta una delle nostre poche superstar amate all’estero, relegato in sale da 100 posti , diversamento da quello di Ettore Scola su Fellini, in Sala Grande alla presenza del presidente Napolitano.
Naturalmente i giornalisti stranieri non capiscono e molti già fanno i bagagli per Toronto che quest’anno, tanto per peggiorare la situazione, ha deciso di anticipare le sue date e sovrapporsi a Venezia, che ha risposto alla sfida con un Festival non solo sobrio di eventi che avrebbero potuto sollevare gli animi, con scarsa prsenza di star e la buca della e impossibile Lindsay Lohan e di Cristoph Waltz con i fan costretti ad inseguire uralando Daniel Radcliffe, anche se somiglia a Daniele Luttazzi, è alto un metro e cinquanta e sembra Harry Potter vecchio; ma manca soprattutto di buon cinema.
Sono mancati i titoli più significativi, come “The Fifth Estate” di Bill Condon sull’inventore di Wikileaks Julian Assange; “12Years a Slave” di Steve McQueen il grande artista- regista all’ultimo atto della trilogia dopo “Hunger” e “Shame” e persino l’italico “Anni Felici” di Daniele Lucchetti, per non parlare di prodotti già pronti per le sale con pubblico garantito come la biofiction su Mandela o il blockbuster “Rush” di Ron Howard ,storia di Niki Lauda in un filmone rombante su Ferrari tutte rosse. Tutti, invece, presenti a Toronto che è ormai (dopo anche il fallimento parziale di Cannes e totale di Locarno), unica cartina al tornasole per i produttori e distributori. Mala tempora currunt per l’itala celluloide, sia in fase di realizzazione che di offerta.
Molto meglio il poverissimo “Cinema sotto le stelle”, che il Comune di Venezia a realizzato nella piazze della laguna in agosto, con la proiezione del bellissimo (perché non è al Festival?) docu-film “Non è mai colpa di nessuno ” di Andrea Prandstraller, interamente girato tra Marghera e Venezia, per non dimenticare chi siamo e dove siamo.
Preferisco concentrarmi, per non rattristarmi, sull’ultimo film del vecchio leone non ancora privo di denti che è Bernardo Bertolucci (ora presidente di giuria), alle sequenze magnifiche di “Io e te”, una ennesima lezione di cinema e di introspezione, applaudito a Cannes (meno in Italia), un ulteriore passo avanti rispetto al troppo carico “The Dreamers” ed un po’ la summa del cinema di Bertolucci, un tipo di cinema che da anni, a Venezia (e altrove), è molto difficile vedere.
(67)