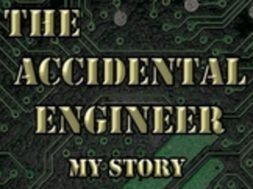“La pelle umana delle cose, il derma della realtà, ecco con che cosa gioca anzitutto il cinema”
Antonin Artaud
“La morte non è che un’abolizione dello spazio e del tempo. Questo è anche il fine del cinema”
Jean Cocteau
57 anni sono pochi per morire anche quando si è molto malati e provati da una lunga lotta contro un nemico subdolo ed invincibile. Padovano, grande e grosso tanto da sembrare eterno come il marmo o il granito, Carlo Mazzacurati, attualmente direttore della Cineteca di Bologna dopo la morte di Giuseppe Bertolucci, si è spento ieri lasciandoci il rimpianto per una mente capace come poche di creare poesia in immagini e l’idea che dietro ad ogni burbero in apparenza, si nasconde la sensibilità di un grande cuore.
Taciturno, barbuto, spesso accigliato, aveva esordito con il sensibilissimo “ Notte italiana” nel 1987, grazie al connubio con Nanni Moretti, altro burbero benevolo, per poi proseguire con una meditata lentezza per altre 19 pellicole, fino all’ultima presentata lo scorso novembre al Torino Film Festival, “La sedia della felicità”.
Aveva vinto il Leone D’Argento con “Toro” nel 1994 e si era inventato Antonio Albanese come attore drammatico.
Nella sua carriera è stato attento alle storie di provincia, alla descrizione di quelle piccole increspature dell’anima che ne rilevano poi il fondo scuro o un’improvvisa inaspettata bellezza, collaborando per lo più nella sceneggiatura, con Umberto Contarello (cosceneggiatore con Sorrentino de “La grande bellezza) e facendo interpretare i suoi personaggi a tre coppie: prima Diego Abatantuono e Roberto Citran, poi Albanese con Fabrizio Bentivoglio e infine Stefano Accorsi e Maya Sansa.
Considero il suo “La lingua del santo” uno dei film più belli degli ultimi anni e l’ho ammirato nel profondo per il coraggio di portare sullo schermo un autore scomodo come Cassola e recuperarne appieno istanze, atmosfere e sfumature, con “L’amore ritrovato”, un film fatto di realismo dolente, mai troppo esibito e di scavo profondo nelle inquetudini dell’animo umano.
E lo ricordo per il remake difficile del film di Comencini “A cavalo della tigre”, del 2002 e per il suo cammeo in “Caro Diario” di Moretti, quando sul letto, piange, subendo la lettura di una recensione del Manifesto di “Harry pioggia di sangue”.
Ma soprattutto lo ricordo per “Vesna va veloce”, del 1996, fiaba ed apologo che non scantona mai dalla realtà, in cui lo scavo nelle anime è speleogico, abissale e ci racconta, con personaggi-emblema tratti dalla quotidianità, della solitudine che oggi ci riguarda un po’ tutti.
Ora che Carlo Mazzacurati è morto immagino che la corsa finale di Vesna in quel film possa essere intesa come una trasfigurazione purificatrice dopo la morte ed anche come rappresentazione della vita breve ma “seria” della’autore, del suo destino di eterno fuggiasco dal brutto, dall’insulso e dal triviale.
Con la sua scomparsa in nostro cinema è più piccolo, enormemente meno capace ed arioso, orbo del suo tocco dimesso che volutamente lascia dietro di sé delle zone lacunose, riuscendo comunque a comporre delle toccanti allegorie di un dolore, d’uno spaesamento malinconico.
E per non sentirmi orfano del tutto, mi riguarderò alla moviola e più volte, la bella scena della danza sulla spiaggia, che evoca nostalgia e poi quella terribile dell’ubriaco ceco che si “perde” nel traffico, per sentire che nella vita dobbiamo aprire gli occhi e non ubriacarci solo di apparenze, ma continuare a danzare, anche se avvolti dalla melanconia.
Carlo Di Stanislao
(90)