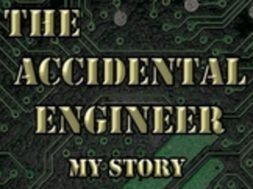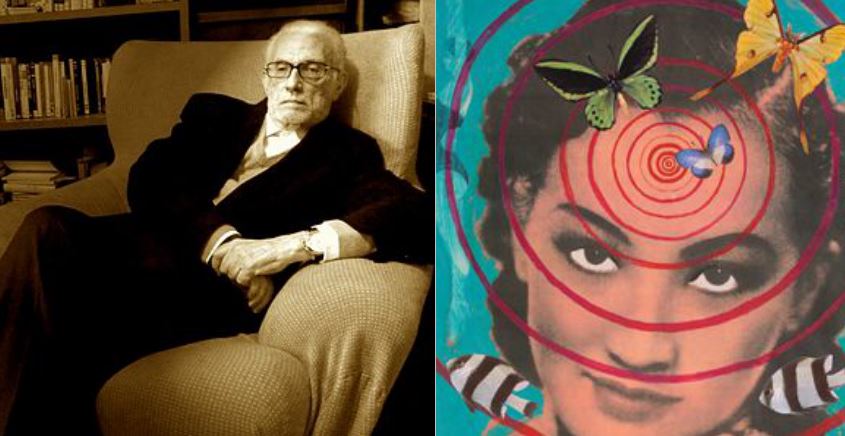
(Di Carlo Di Stanislao) Manlio Sgalambro, scrittore e poeta, canzonettista e sceneggiatore, ma soprattutto filosofo nichilista con influenze di Nietzsche e Cioran, è morto a Catania giovedì scorso, ad 89 anni, lasciandoci una eredità davvero atipica nel panorama culturale italiano, esordendo in tarda età, nel 1982, con quella che probabilmente è la sua opera più rappresentativa: “La morte del sole”, scrivendo e pubblicando poi altri volumi (alcuni dei quali tradotti in tedesco, francese e spagnolo), fra i quali “Trattato dell’empietà”, “Del pensare breve”, “Dell’indifferenza in materia di società”, “La consolazione”, “Trattato dell’età”, “De mundo pessimo” e”Variazioni e capricci morali”, l’ultimo, pubblicato nel 2013; ma soprattutto, dal 84, collaborando alla più parte dei progetti di Franco Battiato: cinque libretti d’opera e sette album musicali e la sceneggiatura di tre film: “Perduto amor”, “Musikanten” e “Niente è come sembra”; riproducendo, in questa variegata produzione, una sorta di percorso verso il grado zero dell’essenza della propria poetica, partendo da una scrittura tradizionale fino ad un viaggio antropologico sulle origini e il senso dell’umano agire che evapora fino alla dissoluzione.
Spesso deriso o non preso sul serio, perché scriveva canzonette (anche per Patty Pravo, Alice, Fiorella Mannoia, Carmen Consoli, Milva e Adriano Celentano), egli resta un esempio di intellettuale coerente nei contenuti che ha reso fruibili a vari livelli e con mezzi differenti, partendo da una concezione beffarda dell’accademismo, scopritore di una nuova via di comunicazione e trasmissione che lo aveva portato, nel 2002, ad essere il bislacco chansonnier, distaccato e senz’altro snob, interprete di un album che si intitolava “Fun Club”, con fior di musicisti e la voce strapazzata dalla vita ma assai espressiva: non solo “La mer” di Trenet o “Non dimenticar le mie parole” di D’Anzi, ma anche: “Me gustas tu, autentico colpo di genio, apostrofo sorridente e un po’ beffardo che lo avvicinò ancor più alle masse giovanili a cui più di tutte intendeva rivolgersi, convinto che da loro e solo da loro poteva partire un vero rinnovamento.
Poco capita, in questi giorni, anche Serena Dandini, che dopo successi e flop si è presa una pausa dalla tv per ricevere un invito dall’Onue portare il suo spettacolo “Ferite a morte” a New York, ma intanto è poco considerata da noi ed è costretta a rinviare l’accarezzato progetto, condiviso con van Cotroneo, di partire da questo testo per una fiction televisiva.
Il suo spettacolo lo aveva presentato a settembre, nel giardino che di una villetta d’epoca, nel cuore di Monteverde vecchio, uno dei più bei quartieri di Roma, quello di Pasolini e dei Bertolucci, con un fiume toccante di parole sul femminicidio, con, sul palco, a interpretare le vittime, quattro donne che si alternano a dare voce a queste storie, in uno spettacolo drammatico, ma giocato, a contrasto, su un linguaggio leggero e con i toni ironici e grotteschi propri della sua scrittura, resa più efficace dalla collaborazione con Maura Misiti, ricercatrice del CNR e a interpretarle Lella Costa, Orsetta De Rossi, giorgia Cardaci e Rita Pelusio.
Quanche distratta recensione e poco altro, nonostante una tournée italiana con 50 tappe e un tour all’esterodi quattro date, perché lo stile è piano e diretto, il tema duro e non piace parlare oggi di femminicidio in una sorta di “spoon river” rivisitato e schietto per dare voce alle troppe donne che perdono la vita per mano di un marito, un compagno, un amante, un “ex”.
(72)