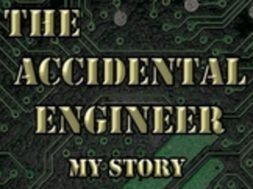Difficile pensare che ‘Un dio furioso’ sia un disco d’esordio. Ciò che hanno confezionato i Na Isna, quintetto carpigiano, è un opera ‘adulta’ con una sua storia, un suo racconto, un unico filo conduttore. La lingua italiana utilizzata dagli interpreti non toglie nulla, anzi forse arricchisce, le bellissime sonorità nord-europee dei dieci pezzi.
Prodotto artisticamente da Enrico Mescoli, Andrea Franchi e Federico Truzzi, “Un dio furioso” è il primo album dei modenesi Na Isna, realizzato presso il Lemon Head Studio di Carpi (MO). Il nome del quintetto carpigiano, che ha origine nello stato africano della Guinea-Bissau, luogo di nascita di Marco Na Isna Lodi (autore di musiche e testi, chitarre e voci), viene usato per ricordare a chi lo porta che è destinato, presto o tardi, a confrontarsi con la propria provenienza, con le proprie radici, e che in un certo senso a quelle appartiene. È dunque significativo che, per incontrare nei testi le parole messe a titolo di questa prima fatica discografica della band, ci sia da scoprirne quasi l’intera tracklist fino alla penultima traccia “Tigri dagli occhi”.
Per trovare le radici, verrebbe da dire, è necessario scavare, fino al verso “mentre tutto tace, lancia tigri dagli occhi (…) è un dio furioso, un vento che solleva monti” – che spiega praticamente tutto: ci sono tigri, in agguato negli occhi di qualcuno, che ci dicono di un “dio” che è in realtà una forza della natura, uno sguardo che in sé trattiene la potenza di un vento capace di spuntare montagne. L’unico vero “dio” di cui l’umanità dovrebbe temere la furia, ovvero la natura. A cominciare dalla copertina, scattata da Angela Tugnetti, viene dunque offerta una chiave di lettura ermeticamente elementare: quella di guardare all’infinitamente piccolo, per provare a comprendere l’infinitamente grande.
 Il nostro “dio” deve essere in quelle radici e in quella terra che sono la nostra origine. Un “dio” d’ecosistema che abbiamo percorso e sfruttato in lungo e in largo, anche se quando si tratta d’imputare a qualche capro espiatorio la colpa delle nostre disgraziate scelte sembriamo perderne la memoria (Canto di migranti); una bellezza apocalittica e catartica che dovremmo invece preservare invocata nel manifesto ideologico Stri-stri. Quella stessa furia degli elementi che ritorna in forma di ballata intimista declinata su una poesia di Arthur Rimbaud (Canzone della torre più alta) o come mantra che (non) chiude un primo ragionamento sul Tempo inteso come oggetto di un atavico desiderio di controllo (Neri mai), mentre altrove accende la danza di uno stato alterato verso una condizione di quiete o di stoica attesa di seconde chances (Un attimo).
Il nostro “dio” deve essere in quelle radici e in quella terra che sono la nostra origine. Un “dio” d’ecosistema che abbiamo percorso e sfruttato in lungo e in largo, anche se quando si tratta d’imputare a qualche capro espiatorio la colpa delle nostre disgraziate scelte sembriamo perderne la memoria (Canto di migranti); una bellezza apocalittica e catartica che dovremmo invece preservare invocata nel manifesto ideologico Stri-stri. Quella stessa furia degli elementi che ritorna in forma di ballata intimista declinata su una poesia di Arthur Rimbaud (Canzone della torre più alta) o come mantra che (non) chiude un primo ragionamento sul Tempo inteso come oggetto di un atavico desiderio di controllo (Neri mai), mentre altrove accende la danza di uno stato alterato verso una condizione di quiete o di stoica attesa di seconde chances (Un attimo).
Dinamiche strumentali e intrecci vocali che guardano fuori dall’Italia, tradendo l’attrazione verso orbite sonore nord-europee e lasciando intendere la curiosità con cui si sono ascoltate la seconda vita dei Radiohead o la prima produzione dei dEUS, Jeff Buckley, The National. Continuamente riaffiorano tracce di radici, come quando il doppio debito verso Dylan Thomas (Il gobbetto del parco, Solleva il viso) si palesa attraverso ragazzacci che giocano a rincorrersi per sfogare la loro quotidiana crudeltà sul “diverso” di turno, e che solo una donna perfetta come un giovane olmo può domare. Il sipario sul teatroumanità viene alzato fino a scoprirne temi portanti, che siano la Storia (Sui tuoi passi) o l’ineluttabilità dei destini generali (Un flusso), per indurre in chi lo ascolta il bisogno di riavviare un dio furioso alla ricerca di dettagli nascosti.
(dire.it)
(19)