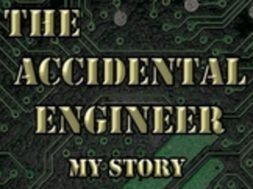(Di Carlo Di Stanislao) Era nato il 6 febbraio di 80 anni fa e dopo un’infanzia difficile, con una vita riscattata dal cinema, è morto a soli 52 anni, stroncato da un tumore cerebrale, 39 anni fa.
François Truffaut, a cui nella ricorrenza della nascita Google dedica il suo doodle (il secondo ad un regista, dopo quello a Fellini), è stato e resta uno dei maggiori registi cinematografici di tutti i tempi, un regista che è stato capace, fra l’altro, di parlare meglio di ogni altro del mondo femminile, di esprimerne la complessità e la magia, capace, in ogni circostanza, di fare scelte e sopportarne le conseguenze.
Scrisse nel 1980 (e riprese la battuta tre anni dopo, in “Finalmente domenica”, suo ultimo film): ““Tristezza senza fine dei film senza donne! Detesto i film di guerra eccetto in un momento in cui un soldato tira fuori dalla tasca una fotografia di donna da guardare “.
La donna, nel cinema di Truffaut, è un universo deciso ed enigmatico, un filtro sensibile di contrasti, con infinite dissonanze ed infinite dolcezze.
Altro tema centrale nel suo cinema è la coppia: quasi sempre in primo piano, più raramente sullo sfondo, con la costante rappresentazione della sua impossibilità a costituirsi o a soddisfarsi.
In lui la coppia si muove sempre tra colpa e ferita, tra una specie di eredità negativa e l’assurdo, tra l’apertura e lo scacco.
Il tema della relazione d’amore e quindi della riflessione sulla coppia e sul suo destino si ritrova soprattutto in alcuni dei film come: “La Femme d’à coté” (1981) ma anche “Le due inglesi “ (1971), oltre al più famoso , Jules e Jim “( 1962).
Nel film “Baci rubati”, dove gli amori vengono cantati attraverso canzoni di Charles Trenet, si dice “che ci si lascia e non c’è niente che spieghi … è l’amore che fugge, l’amore che fugge “ – è la la precarietàche diventa la dimensione necessaria dell’esperienza della coppia.
Il suo film più compito sul tema, resta comunque “La Femme d’à coté”, in cui qualsiasi illusione d’amore assoluto – la mitologia dell’amore romantico – si frantuma, con un finale, famosissimo, che resta come una sorta di epitaffio sul discorso d’amore alla Truffaut : “Né con te, né senza di te”: cioè, d’amore assoluto si impazzisce, si muore, si uccide.
Per Truffaut l’amore si fonda su una sorta di strategia del desiderio: e proprio nell’ottica di una morale “estetica” e nuova Truffaut sperimenta, in altri film, sempre con occhio di particolare riguardo alla figura femminile, prospettive innovative della stessa vita di coppia.
Famoso e centrale, in questo senso, rimane “Jules e Jim”, dove una magnifica Catherine (Jeanne Moreau) è al centro di un esperimento volto a rifondare i rapporti, a riqualificarli secondo una nuova morale dei sentimenti, proprio a partire da un modo trasgressivo di vivere il desiderio, all’insegna del gioco, ma toccando e lambendo però i confini della realtà della morte: “eros thanatos”.
Dal 2 febbraio ad oggi, con una rassegna su quattro titoli, finalmente l’ Institut Français di corso Magenta, a Roma, si è deciso ha celebrare il grande autore, con la proiezione di “Tirate sul pianista”, “La sposa in nero”, “La mia droga si chiama Julie” e “L’uomo che amava le donne”, il mio film preferito in assoluto, anche più dei “400 colpi” o “Effetto notte”, con cui vinse l’Oscar e che sia Time che Ciak, considerano fra i 100 film più importanti della storia del cinema, dedicato alle sorelle Dorothy e Lillian Gish, icone del cinema muto.
A volte grottesco e volutamente inverosimile nella sua trama eccezionalmente intricata, ancora oggi a distanza di tanto tempo si mostra vivace e pieno di ritmo, piacevolissimo nella sua leggerezza e ironia.
Tratto dal romanzo Morire d’amore (The Long Saturday Night 1962) di Charles Williams, non solo omaggia i b-movie noir e, assieme, la sophisticated comedy della Hollywood classica (guardando i protagonisti del film vengono subito in mente Myrna Loy e William Powell, Katherine Hepburn e Spencer Tracy), ma anche la sua compagna Fanny Ardant, qui splendida protagonista assoluta, da lui sposata un paio d’anni prima
Raccontato come un lungo flashback a partire dal funerale del suo protagonista, il film propone momenti di ulteriore ricerca biografica con sequenze che raccontano del rapporto di Bertrand bambino con la madre. Una madre che ha più di un punto di contatto con quella di Antoine Doinel, a confermare ancora una volta la forte componente autobiografica della pellicola.
La madre di TRuffat fu Jeanine de Montferrand, all’epoca appena diciottenne.
Il padre, Roland Truffaut, un architetto-decoratore che riconosce il figlio come suo, pur non essendone il genitore biologico.
Nel 1945, leggendo il diario di Roland, il futuro regista scopre la verità anche se – per accertare la vera identità del padre naturale – dovrà aspettare la fine degli anni sessanta – quando, per esigenze di realizzazione del film Baci rubati (1968), Truffaut contatta l’investigatore privato Albert Duchenne dell’agenzia Dubly, e ne approfitta per affidargli l’ulteriore compito di individuare il suo padre biologico. Viene così a sapere che si tratta di un dentista ebreo, divorziato, che all’epoca viveva a Belfort.
Esita a lungo ma poi decide “di non allacciare i rapporti con il padre ritrovato: era davvero troppo tardi, e poi non voleva creare dei problemi al padre legale Roland Truffaut”.
Fondamentale nella vita di Truffaut, l’incontro con il critico francese Andrè Bazin, che fu il suo protettore e padre spirituale e con il quale collaborò fin dalla nascita di Radio-Cinéma-Télévision (che in seguito diventerà Télérama) e poi, nel ’51, i Cahiers du cinéma, dove incontrò e si formò dal confronto con in futuri cineasti che diedero vita alla Nouvelle Vague.
Appassionato del cinema americano (fondamentale la sua lunga intervista “Il cinema secondo Hirchock”), Truffeau presa dal discorso teorico di Bazin e seppe, con poesia, trasferire sullo schermo, le teorizzazioni relative al realismo al cinema, sviluppando i concetti di realismo ontologico (preso da Rossellini e gli altri del Neorealismo italiano) e di “montaggio proibito”, oltre ad una utile frammentazione fra immagine e suono, che crea, nei suoi film, una voluta divisione e fascinazione tanto in chi crede nell’immagine, che in crede nella rappresentazione della realtà.
Tornando a “L’uomo che amava le donne” (di cui una copia in perfetto stato è nel patrimonio della Cineteca dell’Istituto Cinematografico Lanterna Magica de L’Aquila), nato dalla volontà di lavorare nuovamente con Charles Denner dopo La sposa in nero e Mica scema la ragazza!, ma soprattutto di mettere insieme tutte le attrici francesi con le quali avrebbe voluto lavorare, è forse il film più autobiografico tra quelli di Truffaut che non appartengono al ciclo di Antoine Doinel.
Grazie anche alla collaborazione in fase di sceneggiatura da parte di Suzanne Schiffman (e Michel Fermaud), i già splendidi personaggi femminili tipici dei film di Truffaut acquistano qui un’intensità decisamente fuori del comune.
D’altra parte, avendo al centro del racconto sempre lo stesso personaggio maschile, era assolutamente necessario riuscire a costruirgli intorno un universo femminile di grande impatto. Tanto più che questo film, e di conseguenza l’autobiografia che Bertrand scrive, è quasi una dichiarazione d’amore a tutte le donne del mondo.
Sempre presso la Cineteca aquilana una copia rara (poiché intera, senza i tagli della distribuzione finale nelle sale), di “Finalmente domenica”, omaggio estremo di Truffeaut (che morirà appena terminato il film) al thriller americano, in cui, per riprodurre per riprodurre le atmosfere dei b-movie noir americani degli anni ’50, Truffaut si serve coraggiosamente del bianco e nero, affidandosi allo straordinario talento fotografico e visivo di Nestor Almendros, con cui aveva girato il suo precedente film in b/n: Il ragazzo selvaggio, nel lontano 1969.
In questo film (che abbiamo presentato e commentato al Film Festival Opera Prima di Roseto, due anni fa, con un successo tale da doverne replicare la proiezione, due mesi dopo), struggenti sono, a mio avviso, le ultime immagini lasciateci da, mentre scorrono i titoli di coda: i piedi dei bambini del coro che, mentre si celebra il matrimonio del personaggio interpretato da Fanny Ardant, incinta del figlio del regista, giocano col coperchio di una macchina fotografica.
Estrema dichiarazione d’amore per il mondo dell’infanzia, per le donne e per il cinema.
Altra pellicola conservata nella “nostra” Cineteca, “I 400 colpi” (1959), il primo film del personaggio Antoine Doinel, alter ego del regista, sempre interpretato da Jean Pierre Leaud, che accompagnerà nella vita cinematografica il cineasta francese.
Vero Manifesto della Nouvelle Vague, assieme a À bout de soufflé (1960), di Godard, è un inno, largamente autobiografico, alla libertà dell’infanzia, attraverso le vicende di un bambino, nel quartiere in cui il regista è nato.
E qui vale la pena aprire una parentesi sulla Nouvelle Vague e sulle personalità che la caratterizzarono.
Grazie a questo “nuovo modo”, ispirato da Bazin, le immagini venivano accostate secondo diversi nessi logici, per esempio: per identità quando abbiamo più immagini dello stesso soggetto o, per analogia quando confrontiamo due personaggi o due oggetti.
Questi nessi logici creano un linguaggio sensato, una storia. Il cinema moderno invece, passa ad un linguaggio più libero, disorientativo e anticonformista.
Si tratta di un cinema che parla di se stesso e dei suoi strumenti, che diventa autoreferenziale cioè metacinema. Questo nuovo tipo di arte cesserà di far illudere lo spettatore che si troverà di fronte all’attore della strada e alla sua logica dell’improvvisazione.
Un cinema diverso e attuale, che si apre all’imprevedibilità, alla strada, alla città e non più alla logica degli Studios.
Si tratta di una nuova arte che nasce con la predilezione per il movimento e per gli esterni: pensiamo per esempio a “Ladri di biciclette” di De Sica.
Partendo dagli anni cinquanta, la Nouvelle Vague (letteralmente “nuova ondata”), in particolare con il regista Bresson, esploderà nel ’59 in Francia e giungerà a piena maturazione nel corso degli anni sessanta. Spesso questi film trattano il problema della meccanizzazione e della tecnologia del mondo di oggi: un esempio e’ “Zazì nel metro'” del ’61 di Louis Malle, in cui si passano in rassegna i vari simboli della tecnologia, in particolare la metropolitana. Il film ha come protagonista la bambina Zazie, attraverso la quale vengono derisi temi come droga e sesso, senza dimenticare un certo gusto per la città come dimostrano le frequenti inquadrature dei monumenti di Parigi. Il tema dell’industrializzazione viene affrontato quindi da vari autori; ricordiamo ancora Tati in “Trafic” e il regista Godard in “Week-end” del ’65 che affronta il tema della violenza dell’industrializzazione. Per la sua esemplarità può concludere questa veloce carrellata di esempi il film “Roma” di Fellini degli anni settanta quando ci appare sullo schermo una sterminata fila di macchine in coda sul Raccordo Anulare.
Oltre a Truffaut, Malle e Godard, ne fecero parte Chabrol e Rohmer, personalità molto diverse che, in modo originale, seppero davvero condurre il cinema verso contenuti poetici e narrativi, oltre che stilistici, molto moderni.
Ma gli Autori centrali restano Truffeaut e Godard, con un cinema tanto differente ed insieme, compiutamente affascinante.
Le differenze fra i due sono molte, ma soprattutto mentre il cinema di Godard è prettamente poetico in quanto non è legato ad alcuna struttura narrativa, quello di Truffaut è pura prosa, è struttura narrativa ben leggibile a tutti i livelli.
A questo proposito è fondamentale il rapporto tra Truffaut e la letteratura: basta pensare al film “I quattrocento colpi” tratto dal romanzo di Henry James e a “Jules e Jim” tratto dal primo romanzo dello scrittore settantaquattrenne Rochet.
Truffaut, insomma, instaurava un rapporto di passione con la letteratura, creando un ciclo continuo di film dove il protagonista era sempre lo stesso: Jeanpierre Leaud.
Si tratta di opere in serie nelle quali si sviluppa crescendo e invecchiando una sola vita: quella dello stesso autore.
Il mondo che Truffaut ci presenta, appare privo di angoscia esistenziale, mentre è presente invece, un senso struggente di sconfitta specialmente nelle sue grandi tematiche di fondo: la condizione infantile, la donna e l’amore e raccontare, senza narcisismi, se stessi.
(122)