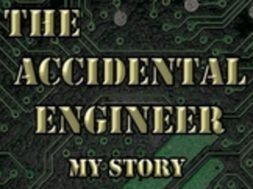(Di Carlo Di Stanislao) La memoria è l’elemento centrale di ogni ricostruzione, la pietra angola di ogni rinascita. Recuperare, attraverso la memoria, l’identità di un gruppo sociale è ciò che va fatto dopo eventi drammatici e distruttivi come un terremoto. Per sapere come ricostruire bisogna, infatti, sapere chi siamo e, per farlo, ricordarci quale passato ci contraddistingue.
Fra le memorie da preservare c’è quella culinaria, capace di rintracciare il senso metaforico del cibo, elemento non solo nutritivo ma identitario come si è visto molto spesso nel cinema ed in letteratura, come accade in “Lezioni di cioccolato” di Claudio Cupellini, o a “Pomodori verdi fritti alla fermata del treno” di Jon Avnet, o nelelebre “Chocolat” di Lasse Hallström, tratto dal libro di Joanne Harris, al più recente e dello stesso regista “Amore cucina e churry”, al divertentissimo “La donna da mangiare” di Margaret Atwood e poi, passando per gli scrittori, a Jorge Amado, che in “Donna Flor e i suoi due mariti” fa cucinare dalla protagonista sontuosi banchetti in cui la fragranza dell’olio di palma, della frutta esotica, della carne di pollo e dei fagioli rende felice e colorata un’esistenza di per sé impostata quasi sulla sopravvivenza.
Il cibo non è solo gusto, ma emozione e ricordo come ci dicono pagine indimenticabili di Proust o capolavori cinematografici provenienti da paesi anche lontani come “Sorgo rosso” e “Mangiare, bere, uomo, donna”.
Come ha scritto oggi il Manifesto, stiamo vivendo un’era gastrocratica contrassegnata da masterchef, social network, esotismi alla moda, invenzione di nuovi prodotti e, a fianco ai palinsesti televisivi pieni di programmi culinari e con cuochi divenuti nuove star nazional popolari, assistiamo a un processo dilagante di valorizzazione e recupero/invenzione di prodotti enogastronomici, a cui si affianca la mania per i cibi esotici considerati miracolosi.
Mangiare le “buonissime” e costosissime bacche di goji sembra diventata la panacea di tutti i mali, e soprattutto dei portafogli degli importatori. Anche il lessico si adegua e parole come tipicità, specialità, prodotto locale, km 0, biologico, naturale, vengono scritte in ogni dove, diventando marche distintive di un certo stile di vita, oppure molto spesso, meri espedienti commerciali.
Come ha scritto in “Cibo come cultura” Massimo Montanari, ordinario di Storia Medievale a Bologna, uno dei massimi esperti di Storia dell’alimentazione, il cibo diviene cultura (e memoria) cultura nella sua produzione, poiché atti l’uomo non si limita a mangiare ciò che la natura offre, ma crea il proprio cibo.
Il cibo, pertanto, diventa cultura quando si prepara, perché l’uomo trasforma il proprio cibo, lo cuoce e lo cucina attraverso l’invenzione delle tecniche più svariate ed è cultura quando si consuma, perché l’uomo sceglie cosa mangiare e cosa no, investendo in questo modo il cibo di un forte valore simbolico.
Saltanto tutta la storia della alimentazione umana e giungendo sino ad oggi, dpopo la terribile omologante industrializzazione del cibo, frutto di una mentalità borghese ed industriale e del pensiero liberal-democratico, che crea il mito del passaggio da una società della scarsità a una società dell’abbondanza in cui mangiare polenta non è più segnale di povertà e la carne è alla portata di tutti; assistiamo oggi ad un superamento di questo modello, con un recupero della territorialità, con un recupero progressivo e capillare della “tradizione” con un revival di certe pratiche, di certe ricette della civiltà contadina in un contesto totalmente diverso, che decontestualizza, pertanto, questi piatti, sottraendoli ai loro antichi significati.
Recuperare un cibo antico è necessario in un concesto analogamente recuperato, al fine di tribuire al’atto del mangiare quel cibo in quel luogo, un preciso significato culturale oltre che alimentare.
Per questo bisogno plaudere ad alcuni che, nel contesto aquilano della faticosa ricostruzione, hanno pensato alla ricostruzione dei luoghi e delle atmosfere, oltre che al cibo, ad artefici di cultura culinaria autenticamente mnemonica come nei casi delle Salette Aquilane, di Ernesto e, a Santo Stefano, de Il Cantinone, luoghi in cuio certi piatti assumono il loro significato e valore primigenio, senza destituzioni e decontestualizzazioni, che ne avrebbero fatto qualcosa di diverso.
Marta Villa, nel saggio pubblicato nel 2010: “Dimmi cosa mangi… Il cibo tra memoria, cultura e identità”, ricorda la celebre frase di Emile Briffault: “La cucina di un popolo è la sola esatta testimonianza della sua civiltà”, per rimarcare tutto questo.
E’ noto il caso delle madaleine di Proust, di sensazioni attraverso il cibo per far riemergere il profondo e, attraverso stimolazioni sensoriali (gustative ed olfattive), far compiere un viaggio emotivo a ritroso, un autentico viaggio nella memoria.
Ed ì questo che accade con gli affettati, i tartufi, gli insaccati, i primi ed i secondi di carne o di formaggi nei tre luoghi indicati, da Ernesto, Le Salette, il Cantinone, luoghi ove si svolge come un rito sacro una antropologia della associazione fra sapore, sguardo e memoria, operazione non soltanto culturale, dove riemerge il passato e l’infanzia, un tempo perduto ma solo esteriormente ed ancora assolutamente vitale ed energico, che riaffiora impetuoso in luoghi pieni di ricordi, dove la potenza dei sapori coniuga i due emisferi cerebrali: il sinistro, parlante e calcolatore al destro, emotivo e sensoriale.
Luoghi consimili e diversi, ciascuno con il suo “spazio” ed il suo “gusto”, interpreti diversificati di una memoria culturale antica e variegata, in cui si coniugano, in modo affatto aquilano, i tre lati del triangolo culinario levistraussiano, cioè i tre apici delle modalità comuni a tutte le culture di trattare gli alimenti: il crudo, il cotto e il putrido, con il primo che costituisce il polo non marcato, mentre gli altri sono fortemente marcati, ma in direzioni opposte; il cotto come trasformazione culturale del crudo e il putrido come sua trasformazione naturale.
In questo modo gli alimenti diventano apotropaici, il contrario di ciò che accade al consumatore di hamburger che, secondo la celebre definizione di Ariés, “diviene un uomo senza storia, senza memoria, che non mangia più per desiderio o per tradizione, ma per bisogno impulsivo o imitativo”.
I luoghi descritti, i tre luoghi in cui cibo e memoria fluiscono senza infingimenti, rappresentano un tracciato da seguiri per la ricostruzione non delle città, delle case, dei monumenti, ma del territorio e, pertanto, dell’autentico “genus loci”.
Gli alberi del bosco, il paesaggio – scrive lo storico Simon Shama – sono storia essi stessi, un patrimonio di ricordi e memorie del territorio, delle sue vicende, delle persone che lo hanno vissuto e che lo abitano ancor oggi”.
Questo dobbiamo tenere presente in questa dificile ed articolata e sempre più caotica ricostruzione. Partire dai luoghi, dalla terra e dai contadini, come, ad esempio, è avvenuto di recente a Parma ed è stato raccontato con infinita passione da Anna Kauber ne: “Le vie dei campi” (Maestri di giardino editori), dove antiche pratiche di coltivazione e di difesa del suolo e dell’ambiente, si sposano con gli strumenti della rivoluzione digitale a cominciare da Internet, dove il paesaggio agrario si fa vernacolo, per usare una espressione di Tonino Guerra, cara allo scienziato-agricoltore indiano Debal Deb, che nella sua nazione combatte una battaglia concreta e produttiva per la salvaguardia dei prodotti e della cultura locale contro l’avanzare spietato e snaturante egli OGM.
Tre sentinelle in tre agguerriti avamposti sono quini Erneto, Le Salete ed il Cantinone, per il recupero di gusto, atteggiamento e memoria, contro una omologazione imperante che ci porterebbe ad essere fantasmi in un territorio ricostruito ma sconosciuto.
(108)