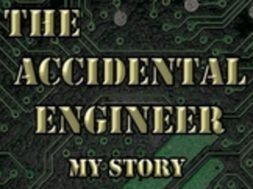(di Carlo Di Stanislao) – Chiuso il rapporto con “Dr. House” e la tv, Hugh Laurie, come aveva detto, si sta dedicando alla musica, ma, pare, tornerà sul grande schermo come “cattivo” nel reboot di Robocop, che la MGM e la Sony stanno preparando, affidandone la regia al brasiliano José Padilha.
Per il remake del celebre film del 1987, Laurie sarebbe in trattative per il ruolo di Richard “Dick” Jones, amministratore delegato della Omnicorp, la compagnia ideatrice e proprietaria di Robocop.
Oltre a Laurie, che dovrebbe interpretare il ruolo che nel film originale era di Ronny Cox, sono stati ingaggiati Joel Kinnaman, per la parte di Alex Murphy/Robocop e Gary Oldman, che sarà lo scienziato Robert ‘Bob’ Borton.
Abbie Cornish avrà il ruolo della moglie di Murphy-Robocop e Samuel L. Jackson sarà un nuovo personaggio: Pat Novak, un potente magnate dei media.
Le riprese del film inizieranno a settembre a Toronto, mentre l’uscita è prevista per agosto 2013.
Prodotto dalla “Orion” e diretto dal visionario e molto incostante (ma spesso geniale), regista olandese Paul Verhoeven, “Robocop – Il futuro della legge” fu un enorme successo di portata planetaria, che diede anche il via a diversi fumetti, due sequel, vari videogiochi e quattro serie televisive.
La Sony Pictures aveva messo in sviluppo una nuova versione di Robocop alla fine del 2005; ma dopo che nessuna informazione circa il progetto era stata più comunicata, nel novembre 2006 il sito Bloody Disgusting riportò che dopo aver tentato di richiamare parte del cast originale, la Sony aveva deciso di non proseguire ulteriormente con il film.
Nel marzo 2008, la MGM menzionò in un comunicato stampa a un possibile rifacimento tra gli sviluppi futuri previsti per la saga.
José Padilha, noto per la serie di Tropa de Elite, in grado anche di vincere l’Orso d’oro a Berlino, alla fine ha convinto le due case che ero ora di tentare, soprattutto avvalendosi, per la sceneggiatura, di Josh Zetumer, autore dello script di Villain e The Infiltrator (diretto da Martin Scorsese e suo unico Oscar per un film), interpretato da Leonardo Di Caprio e ancora di Quantum of Solace e Dune, quest’ultimo affidato a Pierre Morel.
Vedremo cosa resterà (o sarà cambiato), del pessimismo rozzo ma non arbitrario del film di Verhoeven e del catastrofismo sardonico e dello sbeffeggiamento degli yuppie rampanti, dell’originale.
Quanto a Paul Verhoeven, regista turbolento, enfatico, satirico, capace di giocare con i labili confini dell’erotismo sia etero che omosessuale, firma il suo capolavoro, Basic Insinct” nel 1992 e convince critica e pubblico con Starship Troopers – Fanteria dello spazio (1998, ) con Casper Van Dien e Denise Richards, trasposizione cinematografica di un classico di Robert A. Heinlen.
Nel 2006 è tornato nella sua Olanda per girare l’intimista (e largamente incompreso), Black Book, con Carice van Houten, Thom Hoffman, Halina Reijn e Sebastian Koch, in cui, parlando di guerra ed invasione, non smette di provocare, rileggendo le interpretazioni tradizionali e dando corpo alle proprie polemiche ossessioni.
Sempre da un grande successo (il primo) di Verhoeven, “Atto di Forza”, cult movie del 1990, ispirato al famoso racconto di Phillip K. Dick “Ricordiamo per voi”, si sta ultimando un remake diretto da Len Wiseman e prodotto da Toby Jaffe, con Colin Farrell ed Ethan Hawke.
Nel film di Verhoeven il protagonista era Arnold Schwarzenegger e vi compariva, per la prima volta in un ruolo importante, Sharon Stone, che 1980 era stata la passeggera del treno di Woody Allen in Stardust Memories e, dodici mesi più tardi, diretta da Wes Craven nel raccapricciante Benedizione mortale.
Nell’anno di uscita di “Atto di forza”, la Stone posò nuda per Playboy, divenendo icona e sexy-symbol mondiale, per avere, subito dopo, un terribile incidente sul Sunset Boulevard, con numerose fratture che la costrinsero ad una lunga convalescenza.
Ma la bellezza e la grinta restarono intatte, tanto che, nel 1992, grazie alla spudorata performance della killer bisessuale Catherine Tramell, si vide spalancare le porte centrali di Hollywood, che la consacrano come la nuova Faye Dunaway, attribuendole il titolo di “Donna più Sexy del Pianeta”.
Parlando di remake mi piacerebbe che qualcuno riproponesse, con Hugh Laurie nel ruolo che fu di Stallone e sempre la conturbante Sheron Stone (magari con scene meno “scoperte” ed hot), “Lo specialista”, eccellente thriller diretto da Luis Llosa nel 1994 e per il quale la bellissima Sharon ottenne l’ennesima nomination per l’Attrice più attraente, dalla MTV Movie Awards.
Affiderei la regia o al cupo Darren Aronofsky o al graffiante Peter Mendez, con ri-scrittura a John Logan (L’Ultimo Samurai, The Aviator, Coriolano, Rango, Hugo Cabreti e Skyfall) o Paul Haggis (Casinò Royale, Quantum of Solange, Crash e Milion Dollar Baby).
Sarebbe certo un grande successo.
E di digressioni in digressione, mi piacerebbe vederlo, dico Hugh Laurie, in un western crepuscolare, che mostri, magari, la trasformazione antropologica dei cowboy, che oggi sono penetrati in ogni altro genere cinematografico: cowboy hollywoodiani col fazzoletto sul viso, generali dei marines e giudici della corte suprema col volto nell’ombra di un grande Stetson a cupolone.
Un film in cui mostrare, con il suo grande talento, che attualmente i cowboy ci sono anche oltre confine. Per esempio nella Federazione russa, dove il presidente Vladimir Putin si fa fotografare armato di fucile, il piede sulla carcassa di una tigre bianca, come un personaggio di Jack London. Oppure in Francia, dove il presidente (ora ex) Nicolas Sarkozy ha lo sguardo gelido del pistolero e ha sposato in seconde nozze Carla Bruni, praticamente una ragazza del saloon.
Un film pulp alla Tarantino (ma magari affidato ad un autore non americano e modernissimo, come il nostro Sorrentino), in cui si mostri come prima i cowboy abbiano rinunciato a pascolare le vacche, poi abbiano cercato un ingaggio nei gangster film, nel cinema di guerra, nelle pellicole d’azione con Bruce Willis e affini, praticato il kung-fu, recitato nei fantasy come Conan il barbaro o Solomon Kane e, da ultimo, anche in una singolare soap opera gay come Brokeback Mountain.
E poiché, ormai, di Americhe ce ne sono almeno due, quella urbana, l’America dei rapper e del big business, e quella profonda, l’America dei Tea Party e della country music, a tenerle unite è sempre la vecchia weltanschauung: l’amore per l’autogoverno, il culto delle armi, i paesaggi così belli da ammutolire, le prove di virilità e uno smisurato campeggio on the road, fin dove arriva l’occhio e si può spingere il cuore.
Riproporre tutto questo e farlo con un attore inglese ed un regista italiano sarebbe davvero il massimo.
Ho anche un titolo per questo western da fare: “E da bambino il west”, che volentieri regalo ai produttori più intraprendenti e coraggiosi
In attesa che il sogno si realizzi, resto comunque incantato a guardarmi la serie di spaghetti western su Rete 4 il lunedì e mi sdilinquisco “sparandomi” cassette e dvd (ma anche pellicole della Cineteca de L’Aquila che ne possiede a iosa), i film di Ford, Howard Hawks, Delmer Daves, Anthony Mann e gli altri, i cui cowboy uscivano di scena lealmente uccisi in duello, oppure precipitando giù da un dirupo o colpiti da un fulmine, oppure convolavano a giuste nozze, con Maureen O’Hara o Donna Reed.
Dopo questi grandi autori, capaci di un genere in cui avventura e melanconia compongono un miscuglio memorabile, negli anni ’70, il western perde slancio: è considerato un genere da svecchiare politicamente, in particolare nel tentativo di raddrizzare il torto fatto ai nativi americani, diventati i “cattivi” di turno. Ci prova Arthur Penn con “Il piccolo grande uomo”, pessimo film dai toni grotteschi, con protagonista uno spaesato Dustin Hoffmann.
Ralph Nelson, nello stesso anno, propone l’eccellente “Soldato Blu”, atto d’accusa che filtra la tragedia del genocidio dei pellirosse per lanciare un preciso attacco contro l’intervento statunitense in Vietnam. Il film presenta una visione dell’infame massacro di Sand Creek (500 vittime, per la maggior parte donne e bambini) così realistica che molti spettatori dell’epoca svengono in sala.
Un altro classico, sempre del 1970, è “Un uomo chiamato Cavallo”, con il grande Richard Harris che da Lord inglese diventa capo Sioux. Ultimo titolo della rivoluzione indiana degli anni settanta è “Corvo Rosso non avrai il mio scalpo” di Sydney Pollack in cui la lotta personale di vendetta di Robert Redford, sommersa nel faticoso splendore di sterminati paesaggi innevati, termina per stanchezza del sangue. La guerra porta solo guerra, la convivenza è l’unica risposta.
Terminata l’epoca dell’impegno saranno gli sforzi congiunti dei registi Sam Peckinpah e Sergio Leone a cambiare il volto del western. Il primo firma, con “Il mucchio selvaggio” e “Pat Garret & Billy the Kid”, due grandi ballate.
Lo sguardo si sposta verso la fine di un’epoca, l’eroismo diventa malinconico nichilismo, la violenza si sublima nella polvere e nel sangue fino a diventare il mezzo espressivo di una generazione di cineasti intenta a reinventare un genere. I dialoghi di “Pat Garret & Billy the Kid” seguono il ritmo elegiaco delle musiche originali di Bob Dylan (che ne curò la colonna sonora) e diventano una vera prosa poetica, un canto in memoria dell’amicizia tradita e di un passato inafferrabile. La morte comincia ad assumere un peso realistico che era sconosciuto al genere.
Ogni tentativo di rinnovare il western appare un successo ed ogni tentativo di snaturalizzarlo non raggiunge l’intento. Il western, con i suoi temi immortali del viaggio, del conflitto, dell’assedio, dell’amore, si adatta a qualunque rilettura. Ambientata in ogni luogo ed in ogni epoca la sua collaudata formula funziona sempre: che si tratti della Macedonia dei primi del ‘900 (“Dust” di Milcho Manchevski), del pianeta Marte in un lontano futuro (“Fantasmi da Marte” di John Carpenter), di un circo itinerante (“Bronco Billy” di Clint Eastwood) o di una storia di vampiri (“Vampires”, sempre di Carpenter).
Negli anni ottanta, ci sono due autori in a prendere le redini del genere: Clint Eastwood, pupillo di Don Siegel e Sergio Leone e Walter Hill, ex sceneggiatore di Sam Peckinpah.
Hill scrive e dirige uno dei western più importanti della decade: “I cavalieri dalle lunghe ombre”, storia della banda dei fratelli Jesse e Frank James.
Il film è in forte debito con lo stile violento e realistico di Peckinpah, ma trova nella ricchezza dei paesaggi (per una volta non desertici) e nell’eccellente interpretazione del gruppo d’attori, fratelli nella vita e nello schermo ( Stacy e James Keach, Dennis e Randy Quaid, David, Keith e Robert Carradine), la perfetta alchimia per descrivere un west ormai sul confine della modernità. Sarà una nuova cassaforte a tempo a bloccare la banda di rapinatori sotto il fuoco della giustizia e la scena dei loro cavalli che sfondano in sincrono una vetrina d’emporio, per uscire dalla strada principale, entra nella storia.
Clint Eastwood, già distintosi alla regia nell’eccellente “Il texano dagli occhi di ghiaccio” (orribile traduzione italiana del più sobrio “The outlaw Josey Wales”), firma, con “Gli Spietati”, una delle opere più significative, non soltanto di un genere, ma della storia del cinema. “Gli Spietati” rovescia il mito della frontiera mettendo in primo piano la cruda verità: la morte è più che mai atroce ed improvvisa, i protagonisti sono cowboys anziani, protagonisti di leggende che ne perpetuano il mito travisando la realtà dei fatti. La fame, il freddo, la febbre, il bisogno di denaro guidano questi uomini verso uno scontro finale che è l’ultima vampata di vera epica di un genere per il quale rappresenta, al contempo, l’apice e l’elogio funebre. Il tanto amato “Balla coi lupi” è, al confronto, soltanto un’operina educata ed ingenua: una bellissima cartolina.
Se si vuole apprezzare Kevin Costner in cinturone e speroni meglio il recente “Terra di confine”, con il grande Robert Duvall a fargli da spalla.
Duvall che, ne “La colomba solitaria”, un film tivù del 1989 di Simon Wincer, ha interpretato la più bella figura di cowboy della storia della celluloide. Un tesoro da riscoprire. Il western tornerà di moda e non solo grazie a quel meccanismo di corsi e ricorsi che tiene vivo il cinema da un secolo.
Il western tornerà di moda perché è tutt’uno con l’immaginario dell’avventura e, di conseguenza, aderisce al mezzo cinematografico come un guanto.
E se è vero che il cinema è esplorazione, emozione, pulsione verso il racconto dell’ignoto, si potrebbe dire, con un affettuoso nonsense, che è stato questo genere ad inventare il cinema e a rappresentarlo, più di ogni altro.
(75)