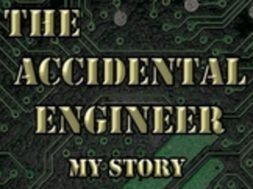(Di Carlo Di Stanislao) Due donne grandi, abissali, coraggiose, sono le protagoniste di un film e di un libro recenti: “C’era una volta a New York”, ultima fatica cinematografica di James Gray con una superba Marion Cotilland e “Tempo di imparare”, romanzo appena pubblicato da Einaudi della sempre profonda Valeria Parrella, già vincitrice del Campiello opera prima e finalista allo Strega, che qui racconta con un “io” diretto, franco, a volte difficile da sostenere, il rapporto tra una madre e suo figlio, un rapporto fatto di piccoli passi, di insegnamenti quotidiani che si susseguono giorno dopo giorno, in un cammino che conduce il bambino verso l’età adulta e lei, la donna, verso una maturità ulteriore, fino a superare la separazione, il difficile momento in cui il binomio madre/figlio cessa di essere, per trasformarsi in due unità distinte. Il percorso è di per se difficile, con un bambino disabile angosciante, perché occorre avere lo sguardo lungo, separare l’ansia dal pericolo vero, vincere, perdere, aspettare, agire, confidarsi, farsi valere, rassegnarsi. La paura è quella di non farcela, e le armi a ben guardare sono le stesse della letteratura: nominare le cose, percorrerle, trasfigurarle, lasciarle andare. Tenendosi per mano – ma chi reggendo chi è difficile dirlo – madre e figlio si muovono tra fisioterapisti e burocrati, insegnanti e compagni di classe, barcollando o danzando, ma sempre stringendo nel pugno una parola difficile che comincia per “H”, e che sembra impossibile far germogliare. Perché se hai tatuato addosso il numero 104 – quello della legge sulla disabilità – e vivi in un mondo “che non ha proprio la forma della promessa”, mettere un passo dopo l’altro diventa ogni giorno piú difficile e l’unico sostegno è la forza di una madre. Una grande madre quella che Valeria Parrella traccia e dedica a sua madre, da poco prematuramente scomparsa, dentro cui si celano drammi, emozioni, sentimenti dirompenti, strazianti, violenti e teneri, con le esperienze datele in sorte che solo la mitologia può restituirne la grandiosità, l’aspetto epico. Fare il nodo ai lacci delle scarpe, colorare dentro i contorni, memorizzare le sillabe in fila, lavare bene i denti anche quelli in fondo, salire scale sempre nuove senza stringere per forza il corrimano. Lei ha occhi lunghi e attenti ed è inesauribile come Ercole nelle 12 fatiche e lui, il bambino, accolto da una madre vera, diviene il sostegno che non si può cercare negli altri.
Personaggio altrettanto toccante e straordinario è la giovane donna polacca protagonista di “C’era una volta a New York” (vedi: http://www.cineblog.it/post/350691/cera-una-volta-a-new-york-nuova-clip-e-featurette-in-italiano-con-intervista-al-regista-james-gray) , costretta, durante il difficile viaggio in mare, ad elargire favori sessuali in cambio delle medicine e del cibo per la sorella caduta malata. Una volta sbarcata, non solo le sarà intimato di mantenere il silenzio su quanto accaduto, ma si troverà bollata come donna di scarsa moralità dai documenti dell’immigrazione., che finisce con l’accompagnarsi ad un prestigiatore e seduttore da strapazzo, che la convincerà ad esibirsi con lui a New York.
Esodo ed epilogo del sogno americano, il film, che vive di atmosfere che ricordano il leoniano “C’era una volta in America”, il film dell’ebreo russo James Gray, è un melodramma in sontuosa cornice storica, potente istantanea di un esodo e prologo ideale delle altre quattro storie raccontate finora, tra mimesi del gangster movie e tragedia famigliare, dall’autore, come ricerca del pezzo da maestro e costruzione di una precisa mitologia registica. Trattandosi di un cineasta dalla cifra e dalle idee tanto chiare, infatti, risulta piuttosto facile fare il gioco delle somiglianze e degli omaggi: alla Little Italy di Scorsese si sostituisce quella Brighton Beach localizzata a sud di Brooklyn (nota anche con il nome di Little Odessa per via dei tanti residenti originari dalla città ucraina), ai battesimi in montaggio alternato di Coppola i Bar mitzvah, alle tradizioni cattolico-italiane quelle ebreo-russe. Ciò che resta straordinaria è la interpretazione della Cottilard, nel tratteggia una dolorosa figura di donna capace, nonostante tutto, di conservare candore ed innocenza fra menzogne e prostituzione. A parte questo il film ha doversi difetti, mesxcolando, spesso malamente e fra molte cadute, le influenze dostoevskiane del precedente Two Lovers (2008), liberissima riscrittura di Le notti bianche, con le dinamiche criminose di The Yards (2000), a tutt’oggi la punta di diamante dell’intera filmografia di Gray, per arrivare ai meccanismi e alle relazioni famigliari di I padroni della notte.
Ciò che rimproveriamo al film (a parte lo straordinario personaggio femminile), è da debolezza che nasce dal fatto di non lasciate intatto il mistero, continuando ad affidarsi alla rarefazione visuale , decidendo di dargli corpo, con una scrittura che non ha la forza di farlo, rischiando, se non fosse stata la Cotilland, di consegnarla ad un’evoluzione di situazioni transitorie e ripetitive.
(65)