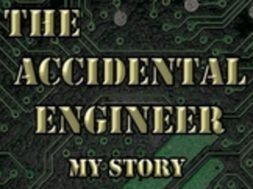(Di Carlo Di Stanislao) Terzo film del duo campione d’incassi Zalone-Nunziante che alza il tiro sulla sceneggiatura ma resta vincolato allo stereotipo vincente della lingua sgrammaticata, delle oscenità porte con un certo stile e con un sottile equilibrismo fra scorrettezze politiche (le donne bersaglio fisso) salvo subito suggerire con un sorriso che era solo una battuta.
Giocato attorno al dilemma dei valori “Sole a catinelle” è un film scontatamente piacevole, con una trama banalotta ad unire le gag del comico pugliese che cerca anche di imitare l’inimitabile Totò, dentro un semplice canovaccio su cui appoggiare le invenzioni comiche (sulla tradizione dei fratelli Marx, tanto per ricordare che può essere una strada di tutto rispetto), ma che non riescono a creare un personaggio a tutto tondo, capace di reggere sulle sue spalle il peso intero di un film.
Si ride, comunque, ed è il motivo per cui la gente fa la fila per andarlo a vedere e noi ne siamo felici perché il cinema è anche questo ed anzi questo cinema porta soldi per un cinema di maggiore spessore ed impegno.
Uscito col faraonico e mai toccato, neanche lontanamente da noi, numero di 1.200 copie in giro per l’Italia, “Sole a Catinelle” mostra un Luca Medici (questo il vero nome di Ceccho Zalone) che si muove tra buonismo e farsa sociale, interpretando ora un “superpapà” sui generis, ora un ometto qualunquista e maschilista, e dipingendo l’italiano medio(cre) che sogna l’arricchimento a tutti i costi a scapito dell’impoverimento d’animo.
Il tema, anche se non nuovo, è sviluppato però in modo confuso e superficiale, con molta gag fra scontate e più divertenti (la zia tirchia in fin di vita preoccupata per il costo della corrente, il bambino dal mutismo selettivo che si scopre logorroico), con la voglia (sacrosanta) di prendere in giro i grandi temi d’attualità, come la crisi, la malattia, l’eutanasia, l’evasione fiscale, ma venendo meno una solida base culturale e riflessiva.
Per quanto riguarda gli altri titoli in sala nel passato wek-end dei Santi, si segnalano: la commedia sentimentale “Before Midnight” di Richard Linklater, l’horror “Smiley”, opera-prima di Michael J. Gallagher, la fantascienza di “Ender’s Game”, firmata dal regista Gavin Hood, e “Captain Phillips – Attacco in mare aperto” diretto da Paul Greengrass e interpretato da un efficacissimo Tom Hanks.
Dalla Spagna arriva un curioso film muto dei nostri giorni: “Blancanieves” di Pablo Berger, già candidato agli Oscar e di cui si dice che è grande come “The Artist”, mentre Valeria Bruni Tedeschi ci racconta la storia della sua famiglia in “Un castello in Italia” e dalla Grecia giunge uno dei trionfatori dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia, il cupo dramma familiare “Miss Violence”.
Infine un film italiano che sarà probabilmente molto amato dal pubblico,:”Zoran il mio nipote scemo” di Matteo Oleotto (esordio alla regia), ambientato nella provincia di Gorizia, a due passi dal confine sloveno, dove si racconta di un 40enne, Paolo Bressan, che lavora svogliatamente in una mensa per anziani, trascorre le sue giornate in un’osteria e insegue senza successo l’idea di riconquistare la sua ex moglie. Le cose cambiano quando scopre di aver ricevuto in eredità da una vecchia zia slovena un nipote: Zoran, uno strano quindicenne che sembra anche un po’ ritardato.
L’esordio di Oleotto è apprezzabile per l’ironia e l’amarezza del racconto e, soprattutto, per il coraggio di avere come protagonista un personaggio sgradevole, antipatico, cinico ed egoista come quello straordinariamente interpretato da Battiston, ma che proprio per questo non manca affatto di umanità.
Delude invece fortemente “Un castello in Italia”, terzo lungometraggio diretto da Valeria Bruni Tedeschi, un film incapace di trovare il giusto equilibrio tra i registri, dal grottesco al drammatico, artificioso e forzato, i cui difetti partono da una sceneggiatura scritta in modo davvero grossolano. Alcune sequenze vorrebbero essere saudentemente erotiche, sul modello dei dipinti giapponesi contenuti nel celeberrimo: “Il canto del guanciale”, con dodici indimenticabili scene erotiche create dal genio di Utamaro nel 1788, pubblicate dal più raffinato editore del l’epoca, Tsutaya Juzaburo, esposte in questi giorni nella mostra Shunga. Sex and pleasure in Japanse art aperta al British Museum di Londra ed invece che languidamente affascinanti si mostrano del tutto prive di vero mordente ed incapaci di descrivere la bellezza femminile ed i piaceri dell’eros.
Molto più contenute, anche sotto il profilo erotico, “”Smiley”, opera-prima del francese Michael J. Gallagher, che fino allo scorso anno filmava solo corti visibili su youtube, intepretato da Caitlin Gerard, Melanie Papalia, Shane Dawson, Andrew James Allen e Liza Weil, ispirato, come dice il titolo, alla faccina gialla sorridente usata nei telefonini e online, uno slasher che ariva da noi con un anno di ritardo, poco apprezzato in patria ma di grande successo negli USA.
Quanto agli altri arrivi stranieri, il più blasonoto è “Miss Violence” del regista greco Alexandros Avranas, film-scandalo dell’ultima Mostra di Venezia, dove ha conquistato il Leone d’Argento per la regia e la Coppa Volpi a Themis Panou, dove incesto, suicido, violenza e pedofilia, accade in una famiglia, sotto il pugno di ferro di un padre-padrone davvero terrificante.
La protagonista Themis Panou, merita il biglietto da sola, ma lo merita anche iil film che è un interno familiare con luci basso-grigiastre come in nessun film americano, francese e neanche italiano, dove si festeggiano, sulle note di “Dance to the End of Love” di Leonard Cohen, gli undici anni di una Angelica, in vestitino bianco casto come le altre ragazzine della famiglia, che seraficamente poi si getta dalla finestra uccidendosi.
Quasi interamente ambientato nella stessa grande casa, “Miss Violence “è una favola dark e di poche parole: asettica e chirurgica, che ci lascia lì a interrogarci sulle ragioni di un suicidio limpido, e sulle dinamiche e le parentele della famiglia di cui spiamo la minimale, inquietante, quotidianità.
Non meno inquietante è lo spagnolo “Blancanieves”, completamente muto e in bianco e nero, diretto da Pablo Berger, vincitore di ben dieci premi Goya (gli Oscar spagnoli), rivisitazione in chiave macabra e grottesca della celebre favola dei fratelli Grimm, con protagonista la piccola Carmen, figlia di un ex torero paralitico e di una cantante morta dandola alla luce, che viene cresciuta dalla nonna danzatrice di flamenco e alla morte di quest’ultima va ad abitare dalla perfida matrigna, seconda moglie del padre, che la detesta e la tratta con sadico dispotismo tanto da desiderarne la morte.
Ormai adolescente, verrà salvata da una compagnia di nani girovaghi che la introdurranno al mondo della corrida: con il soprannome di Blancanieves, che sfrutterà al meglio i consigli paterni per diventare una talentuosa torera.
Ma non ci aspetti un finale tranquillizzante da un film paragonata a “The Artist”, ma che a differenza del francese non appare mai gratuita e, al contrario, sceglie strade complesse e coraggiose sia dal punto di vista estetico, sia da quello contenutistico, come lo splendido finale sul freak show e sui fenomeni da baraccone, un finale spietato e commovente come “Freaks” di Tod Browning, con i personaggi delle favole che vengono trasformati in merce mostruosa da vendere al miglior offerente.
“The Hanger games: la ragazza di fuoco”, prende le mosse dal ritorno a casa di Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), vincitrice insieme all’altro tributo Peeta Mellark (Josh Hutcherson) dei 74mi Hunger Games. Katniss e Peeta sono obbligati a un “Tour dei Vincitori” che li porterà in tutti e dodici i Distretti di Panem. Nel corso di questo viaggio Katniss percepisce i primi fermenti di una ribellione, ma Capitol City governa ancora Panem con il pugno di ferro: il presidente Snow si appresta ad annunciare la 75ma edizione dei Giochi, il cosiddetto Quarter Quell (Edizione della Memoria). Un torneo “giubilare” che si tiene ogni venticinque anni, con regole ancor più crudeli del solito, e che potrebbe cambiare Panem per sempre. Come il primo episodio semina riflessioni politiche e strizza l’occhio ai giovani scavando in profondità e proponendo uno spettacolo non completamente superficiale.
Concludiamo con il trio Linklater-Hawke-Delpy, che in “Bwefore Midnight” racconta il terzo (e forse ultimo) episodio dell’amabile storia d’amore fra due giovani, poi meno giovani, alle prese con sé stessi, con l’altro, col loro amore; in altre parole con la vita, in una vicenda che si snoda attraverso la bellezza di vent’anni, reali, non fittizi e con loro, Jesse e Celine, che sono cresciuti e con la loro relazione, a distanza o vissuta fianco a fianco, che è maturata, come il buon vino.
In questo terzo episodio siamo in Grecia, patria ancestrale di quella filosofia che aspira alla saggezza; quest’ultima impunemente e sciaguratamente associata alla vecchiaia, dove altri dieci anni si sono assommati ai dieci precedenti e nel frattempo la vita ed il rapporto di Jesse e Celine è andato avanti. Tanto, troppo tempo è trascorso da quel pomeriggio in un piccolo appartamento parigino. Ora i due vivono assieme ed hanno due figlie, gemelle. Si direbbe l’epilogo perfetto. Per fortuna non è così. Sarà l’aria che si respira, il buon cibo, la buona compagnia, ma l’estate greca è foriera di bilanci. Jesse sempre più roso dalla lontananza del figlio che vive dall’altra parte del mondo; Celine che di riflesso avverte sé stessa e le proprie figlie come un impedimento per la felicità del compagno.
Col disincanto di chi ha oramai ha capito che la vita non è un semplice accumulo di esperienza, Linklater, Delpy ed Hawke ci mostrano l’ordinario col filtro dolce di chi sa raccontare e può farlo, attraverso una macchina da presa, che senza troppi fronzoli non smette mai di indugiare su un amore imperfetto, e proprio per questo vero ed amabile.
(81)