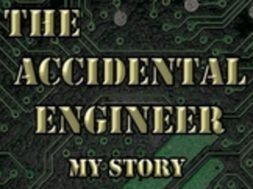(Di Carlo Di Stanislao) E’ stato ucciso da un vizio contro cui ha lottato, inutilmente, un vizio oscuro e che prende molti nel suo mondo, fatto di lustrini ma anche di tanto cinismo e totale isolamento.
Nel 2006 aveva vinto l’Oscar per “Truman Capote-A sangue freddo” e pochi giorni fa aveva presentato al Sundance Festival “A most wanted man”, tratto da Le Carrè, e “God’s Pocket” di John Slattery.
A settembre aveva ritiratato la Coppa Volpi per “Master” ed era impegnato, ironia della sorte, nelle riprese della serie televisiva Happyish, nel ruolo di Thom Payne, personaggio (con moglie a carico) senza più timone, in una società dominata dal culto per l’estetica, un uomo alla ricerca di una felicità che ormai sembra irraggiungibile, come il suo personaggio, del 1998, in “Happinees”, una delle tappe più importanti della sua filmografia.
Aveva solo 46 anni Philip Seymour Hoffman ed era uno degli attori più apprezzati della sua generazione, morto per una overdose nel suo appartamento del Greenwich Village di New York al 35 di Bethune Street.
Nella sua più che ventennale carriera si era fatto applaudire in film come “Scent of woman”, “Boogie Nights”, “Il grande Lebosky”, “Magnolia” “Il talento di Mr. Ripley”, “Le idi di marzo”, mostrando un talento puro ed una inesauribile capacità interpretativa.
A quanto pare è stata l’eroina a sopraffarlo, già sua compagna in gioventù, in cui era ricaduto negli ultimi tempi, dopo un tentativo di disaffezione nella primavera scorsa.
Poco o niente si sapeva di lui, privatamente ed il suo “rehab” dichiarato non aveva fatto notizia, quanto invece continuava a farla la sua capacità trasformistica in un cinema americano che da oggi dovrà fare a meno di una delle sue stelle più vivide, straordinario interprete che aveva iniziato negli anni ottanta e mostrato in decine di film (ma anche nel teatro, con un Tony Award assegnato nel 2000) come superare i limiti di un fisico non da star per dribblare presto la trappola dell’attore-spalla ed imporsi come protagonista. “Nel mio lavoro ho cercato di capire, così come aveva fatto Capote, perchè la gente fa certe cose, che tipo di vita conduce, che cosa la porta a prendere certe decisioni»”, aveva detto nel 2006. Anche se preferiva non parlarne, Philip Seymour Hoffman aveva una compagna, la costumista Mimi O’Donnell, e tre figli piccoli, un maschio di 10 anni e due femmine di 8 e 6: “Sono una persona riservata, non penso che, solo perchè faccio questo lavoro, la mia vita debba essere automaticamente un libro aperto”.
Ora quel libro si è chiuso per sempre, con solo in copertina le sue interpretazioni, la sua capacità di abbandono, la propensione (ed il rischio) della immersione totale, con un fisico ben piazzato, la carnagione chiara e lentigginosa, lo sguardo intenso, usati per le mille sfumature dei suoi personaggi. La sensibilità dell’infermiere di Magnolia, l’abilità manipolatoria del santone di The Master, l’insicurezza del professore represso della Venticinquesima ora, il fascino comico del deejay di I love radio rock, la provocazione lasciva del gay di Boogie Nights, la perfidia del nemico di Tom Cruise in Mission Impossible 3, la disperazione criminale di Onora il padre e la madre, lo spietato fiuto politico di Le idi di marzo, il talento sofferto e luminoso di Capote.
E’ stato un fragile cercatore della felicità Philip Seymour Hoffman, un uomo che ha cercato, nel cinema, la possibilità di interrompere la funzione regressiva della separazione fra mente e corpo che è propria di chi fa uso di eroina e di chi, come ci dicono gli esperti, cammina (e a volte cade) nel disperato processo che aspira a ricostruire l’unità mente/corpo e il conseguente vissuto di unificazione.
In persone come lui, si è scritto, facilmente l’angoscia diventa incontrollabile fino a giungere al panico, mentre l’aspettativa di nuove sofferenze, rende incontenibile la situazione, fino all’epilogo tragico ed unico della fine.
(108)