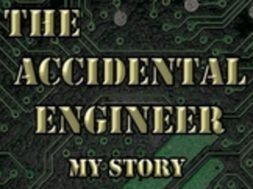(Di Carlo Di Stanislao) Dieci minuti di applausi scroscianti alla fine della proiezione di “Sacro GRA” di Gianfranco Rosi, l’ultimo film italiano in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, storia con personaggi surreali nel luogo-non luogo del Grande Raccordo Anulare che, per un’ora e mezza si trasforma in un compendio di varia umanita’, come quella che si incontrava, un tempo, solo nelle periferie della grande citta’.
Nell’ambito di un’operazione che quantomeno prosegue il discorso intrapreso da La grande bellezza di Sorrentino, Rosi “zoomma” su quella verità di fondo che si vuole in qualche modo imprimere su pellicola. Non solo perché, banalmente, il suo è un documentario, ma soprattutto per il sano distacco da quel contesto non di rado grottesco, che non viene né esaltato né demolito ma semplicemente registrato. Un po’ tenero, un po’ spietato, il ritratto di “Sacro GRA” è in ogni caso verace, anche se magari non del tutto genuino (ma ci sta). Una piacevole sorpresa, oltre che ennesima scommessa vinta per via di un rischio in linea col coraggio mostrato dai selezionatori quest’anno.
Bellissimo anche “Stray dogs”, film in concorso (e tra i favoriti) del taiwanese Tsai Minng-Lian, realizzato con una serie di piani-sequenza impeccabili per creare una sorta di discontinuità narrativa, con la fotografia al centro della rapprsentazione, con luce, colore, angolazione, tessitura di immagine e durata di ogni singola inquadratura, accuratamente studiati affinchè la forma diventi contenuto, come accade nel grande cinema da Wells a Kurosawa.
In “Stray Dogs” l’obiettivo più importante, dalla sceneggiatura alle riprese e al montaggio, è stato limare il racconto, abbandonare la cosiddetta “trama”. Non c’è alcun nesso diretto tra una scena e la scena successiva, quindi si ha la sensazione che non ci sia un inizio né una fine, ma al tempo stesso si percepisce una rottura nell’immediatezza che è molto vitale. Ogni scena è un’azione completa dell’attore e avviene in tempo reale, cogliendo la naturale alternanza di luce e ombra e i cambiamenti dei rumori in sottofondo.
In colnferenza stampa ha detto il giovane regista che anche se il mondo sembra cambiare costantemente, tutti i suoi problemi restano sempre la povertà, la fame, la guerra, il potere, il desiderio, l’avarizia, l’odio ed aggiunto che mentre girava questo film pensava spesso a un’espressione di Lao Tze: “Il cielo e la Terra non agiscono per benevolenza; trattano tutte le cose come cani di paglia” [Tao Te Ching, Cap. 5].
Per cui ha immaginnato molte vicende intrecciate di poveracci e dei loro figli, che sembrano abbandonati dal mondo, pur dovendo comunque vivere.
Ci ha suggerito l’autore che il film ricorda per molti verso uno dei suoi film preferiti: “La morte corre sul fiume”, con un fratello e una sorella che sfuggono dalle grinfie di Robert Mitchum, salgono su una barca e si lasciano trasportare dalla corrente: tutte immagini che ci rimandano a remoti e misteriosi sogni d’infanzia. Ed è questo tipo di cinematografia, estremamente pura che permea “Stray Dogs”, dalla prima al’ultima inquadratura.
In questo film, fra le molte cose (come le canzoni tradizionali cinesi, care al regista) c’è anche il volto di Lee Kang-Sheng, che inizia a gonfiarsi quando passa la quarantina, e il suo corpo che man mano sfugge al controllo e ricorda lo spaventoso e deforme personaggio di Robert Mitchum nel film diretto nel ’55 da Charles Laughton, trasposizione de “Il nudo e il morto” di Mailer, ogetto di culto di molti cinefili fra cui, evidentemente, Ming-Lian e già citato apertamente da Neil Jordan nel suo “In compagnia dei lupi”.
Tsai Ming-liang è originario della Malesia, ma è diventato uno dei maggiori registi di Taiwan. Un autore molto noto il cui Aiquing wansui (Vive l’amour, 1994) ha vinto il Leone d’Oro alla mostra di quell’anno. Con il passare del tempo ha sempre più raffinato e spinto all’estremo il suo stile fatto di lunghissimi paini sequenza, sequenze buie filmate sotto scrosci d’acqua continui e immagini ferme mantenute tali per molti minuti. Sono caratteristiche che segnano opere suggestive come Dong (Il buco, 1998), Bu san (Ultimo spettacolo al cinema Dragone, 2003) e che ritroviamo in Jaojou (Cani randagi). Il film si apre con una sequenza lunga oltre gli otto minuti in cui compare una donna che si pettina guardano i figli che dormono e si procede sulla medesima strada e con lo stesso ritmo seguendo il padre dei pargoli che, dopo averli sottratti alla madre, vive di piccoli lavori, ad esempio fa l’uomo – cartello per la pubblicità di un’immobiliare all’incrocio di una strada super trafficata e, ovviamente, sotto la pioggia. Di notte il terzetto trova rifugio in una casa abbandonata, mentre la madre – impiegata in un supermercato alimentare – continua a cercare i ragazzi e il marito. Alla fine ci sarà un’effimera ricongiunzione ella famiglia in occasione del compleanno dell’uomo, ricongiunzione siglata da un’immagine quasi fissa di moglie e marito – l’uno alle spalle dell’altra – che guardano un affresco che raffigura la riva pietrosa di un fiume o di un lago. Quest’immagine dura oltre i quindici minuti e sintetizza la condizione di blocco in cui si sono venuti a trovare questi cani randagi, veri detriti umani dello sviluppo economico forsennato che ha segnato anche Taipei. E’ un film di non facile visione e di ardua lettura, ma è anche un esempio del migliore cinema contemporaneo. Qualche collega non ha gradito il modo come il regista guida il racconto ravvisandovi una sorta di maniera. Noi, al contrario, vi abbiamo visto un segno di coerente continuità con quello che continua ad essere uno degli autori più interessanti del panorama contemporaneo.
Ieri, a Venezia, anche “La jalouise” di Philippe Garrel, girato nel solito bianco e nero garrelliano, che vede il trentenne, squattrinato attore teatrale (il figlio di Philippe, Louis, già interprete di “The dreamers” di Bertolucci) vivere una storia d’amore con una donna. L’uomo ha una figlia nata da una relazione con un’altra ed ora è follemente innamorato della nuova compagna (Anna Mouglalis), anche lei attrice, ma senza lavoro. L’uomo fa di tutto per trovarle una parte, ma invano. La donna, intanto, lo tradisce, così l’uomo si sparerà un colpo al petto, ma la pistola gli sfugge di mano e, invece di colpire il cuore mortalmente, finirà con un polmone perforato.
Il film è molto bello e rischia di vincere, soprattutto perché Bertolucci presiede la giuria. Quando infatti Nernardo Bertolucci nel 1983 presiedette per la prima volta la giuria del Concorso di Venezia premiò “Prenom: Carmen” di Jean-Luc Godard dicendo che uno dei suoi maestri della Nouvelle Vague non aveva mai vinto e che era giunta l’ora. Leone d’Oro per diritto di carriera per un Bertolucci che potrebbe ripetere l’exploit anche nel 2013 insistendo coi colleghi giurati per quel Philippe Garrel, classe ’48, amico di lunga data del regista parmigiano e proveniente da quella corrente storica della cinematografia francese a cui entrambi si sono devotamente rapportati.
A Venezia è arrivata (ancora sensualissima) Katharina Miroslawa, per prsentare, alle Giornate degli Autori, “Venezia salva” di Serena Nono, pellicola in costume recitata da una compagnia di attori senza tetto, e ispirata alla tragedia della filosofa francese Simone Weil, che racconta il tentato sacco di Venezia del 1618 da parte di un gruppo di congiurati spagnoli e in cui la Miroslawa ha una parte, piccola, come cortigiana.
Ha chiesto ai giornalisti che le si assiepavano attorno: “Per favore, scriva un pezzo glam!”, raccomandazione non così scontata (scrive Vanity Fair) ., visto che di glamorous la sua tragica storia ha poco: l’ex ballerina polacca oggi 51enne, al centro di un noto caso di cronaca nera, è tornata in libertà a giugno, dopo otto anni di latitanza e dodici di detenzione, scontati alla Giudecca. Protagonista di quello che lei definisce un “thriller psicologico”, Katharina, assassina per la legge, innocente per proclamazione, per molti vittima di ingiustizia, nel 1993 è stata condannata per concorso morale nell’omicidio di Carlo Mazza, un industriale di Parma di cui era amante, e che il 9 febbraio 1986 venne trovato morto nella sua auto. A compiere materialmente il delitto, per sua stessa ammissione, l’ex marito della Miroslawa, Witold Kielbasinski, accecato dalla gelosia.
Oggi tutti i condannati sono di nuovo liberi (oltre ai coniugi, anche il fratello di lei) e se si torna a parlare di questo caso è perché la Miroslawa, trasferitasi intanto a Vienna, chiede la riapertura del processo, assistita dall’avvocato Paolo Righi (lo stesso di Nicole Minetti al processo Ruby, ma anche perché il 20 settembre uscirà per Vannini Editrice il suo libro-verità, scritto con l’agente dei vip (e suo) Rody Mirri e intitolato “Peccato…” (con i tre punti di sospensione). “Mi piacerebbe che si facesse un film tratto dal mio libro: la sceneggiatura è perfetta per Roman Polanski, solo lui riuscirebbe a ricostruire la mia storia, che è un thriller psicologico incredibile. Dovrei tradurre il libro in polacco e mandarglielo”, ha detto la Miroslawa ai giornalisti.
Tornando ai film presentati ieri, si possono dire molte cose pro e conto “Återträff” (La riunione) opera prima dell’attrice e regista svedese Anna Odell, ma non si può negare che sia un’opera che tenta strade non consuete. Non si può dire che il progetto sia riuscito in tutte le sue parti o che non vi sia una sovrabbondanza di cose dette in rapporto a quelle mostrate. Ciononostante l’operazione appare davvero originale e le intenzioni più che nobili. Per rendersene conto basta mettere da parte l’idea – ampiamente solleticata nella prima parte – di trovarsi davanti uno di quei film, soprattutto nordici, in cui una qualsiasi occasione conviviale diventa motivo per lo svelamento degli scheletri chiusi negli armadi.
Anche Giovanni Allevi al Lido di Venezia in occasione della presentazione in anteprima del cortometraggio “Symphony of Life” del cartoonist Marco Pavone, un corto d’animazione in computer grafica accompagnato dalle musiche del giovane compositore.
Fra i corti segnaliamo “Insieme”, progetto nato da OncoMovies (in collaborazione con Donna Salute onlus, Società italiana di Psico-oncologia, l’azienda farmaceutica MSD, Pro Format Comunicazione), di appena 13 minuti, ispirato a una storia vera, girato da Anna Maria Liguori e che parla di Angela che va a trovare la sorella Laura poco prima che quest’ultima cominci la chemioterapia. Mentre però corre verso la sorella, Angela incontra Luca, un ragazzo che aveva conosciuto Laura pochi giorni prima e si era innamorato di lei. La presenza di questo nuovo amore permette alle due sorelle di affrontare con serenità la dura prova. Un po’ come “Love Story” ma con molta più serenità nel messaggio che invia.
Domani il Festival chiude (in attesa del verdetto della giuria e della cerimonia di consegna dei Leoni e degli altri premi, sabato 7), con, per Orizzonti, “La prima neve” di Andrea Segre, storia di integrazione e conflitti familiari ambientata fra le montagne del Trentino; fuori concorso “Unforgiven” di Lee Sang-il, remake made in Japan de “Gli Spietati di Clint Eastwood; la consegna a Enzo D’Alò del Premio Bianchi assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici italiani; ma, soprattutto, la cerimonia di consegna a Ettore Scola del premio Jaeger-LeCoultre – Glory to the Filmmaker Award, con a seguire, in Sala Grande e alla presenza di Giorgio Napolitano, “Che strano chiamarsi Federico!”, dove Scola racconta Fellini a venti anni dalla morte in occasione del ventennale della morte del regista.
Ciò che più mi resterà nel cuore, in questa 70° edizione, sono comunque i 70 cortometraggi realizzati da altrettanti registi per il progetto speciale Venezia70 – Future Reloaded: un’idea per celebrare, in totale libertà creativa, e attraverso film brevi dalla durata compresa fra 60 e 90 secondi, il traguardo delle 70 edizioni raggiunto dalla Mostra. Un progetto che finisce anche per riflettere sul futuro stesso del cinema, filtrato dalla sensibilità personale di ciascun regista: si pensi ad Abbas Kiarostami, che mette un bimbo dietro la macchina da presa per dare l’azione e lo stop al “remake” de L’innaffiatore innaffiato dei fratelli Lumière, o a Shirin Neshat, che traendo ispirazione da Ottobre e La corazzata Potëmkin di Ejzenštejn, “reinventa” la storia, e il cinema, facendo indietreggiare i cosacchi dello zar al cospetto della madre con in braccio il figlio ferito a morte, rileggendo la celebre sequenza della scalinata di Odessa. E ancora a Non arrenderti di Amir Naderi, con carcasse e fossili di pesci sulla riva, poi una mano che accarezza pizze di pellicola accatastate. E la stessa mano che dalle acque di un fiume trae in salvo un piccolo pesciolino. Nell’insieme non mancano anche notevoli spunti riguardanti le nuove frontiere della fruizione: Atom Egoyan, con Butterfly, è costretto a fare spazio sulla “memoria” del proprio smartphone e, per farlo, ci mostra per l’ultima volta un video realizzato ad Amsterdam in cui riprende le fotografie di Anton Corbijn esposte in un museo. L’immagine si chiude proprio sulla celebre “Tricky”, opera del fotografo e regista olandese, ed Egoyan ci spiega come – eliminandola – la farfalla incastonata nel petto del ragazzo tornerà ad essere libera. Il macedone Milcho Manchevski, invece, prende spunto da un video che fece il giro della rete qualche tempo fa (quello della donna cinese investita da un camion e rimasta a terra tra l’indifferenza dei numerosi passanti), per soffermarsi sulle derive che potrebbero condurci ad ignorare quello che accade sotto i nostri occhi pur indignandoci vedendo frammenti di immagini provenienti da chissà dove. Emblematico, tra gli altri, il corto di Edgar Reitz, che alla Mostra porta fuori concorso Die andere Heimat – Chronik einer Sehnsucht: la sala di un cinema si svuota, un uomo rimane solo, in lacrime, al termine della proiezione. Esce, e per strada ritrova i “compagni di visione”, già intenti a maneggiare telefoni e tablet, pronti ad altre “fruizioni”. Fuori è un esplosione di immagini, colorate, sovrapposte, veloci: l’uomo entra in un locale, si avvicina al bancone, il barista sfoglia il proprio tablet. E l’uomo, prendendo il proprio smartphone, decide di appuntare sul blocco note il ricordo della serata: “Sono stato al cinema. Ho pianto” (firmato Franz Kafk).
Non manca, naturalmente, il contributo dei registi italiani: il presidente di giuria Bernardo Bertolucci ha realizzato Scarpette rosse, citando l’immortale capolavoro di Powell e Pressburger, inquadrando però i suoi piedi e le ruote della carrozzella durante una difficile passeggiata sui sanpietrini romani, Guido Lombardi con Senza fine rende omaggio alla celebre battuta di Via col vento (“Francamente, mia cara, me ne infischio”), Ermanno Olmi realizza La moviola, Salvatore Mereu Transumanza, Davide Ferrario Lighthouse, Franco Maresco rispolvera personaggi e atmosfere da “Cinico Tv” per i caratteristici auguri alla Mostra, Placido si interroga sul futuro del cinema italiano, poi Giuseppe Piccioni, Pietro Marcello, Antonio Capuano, Franco Piavoli. Un flusso di immagini, talvolta parole, testi, fotografie: il mondo del cinema (impossibile citare tutti i registi presenti, immancabili gli habitué della Mostra come Kim Ki-duk e Shinya Tsukamoto, Brillante Mendoza o James Franco, più veterani come Krzysztof Zanussi, Leone d’oro nell’84 con L’anno del sole quieto, Monte Hellman, Amos Gitai – quest’anno in concorso con Ana Arabia -, Paul Schrader – presidente di giuria in Orizzonti e fuori concorso con il film The Canyons -, Haile Gerima, Catherine Breillat, Júlio Bressane e altri ancora.
(45)