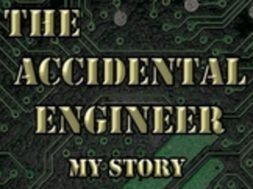(di Carlo Di Stanislao) – Fotografie dentro e fuori dal set, sequenze immortali dall’infinità dei suoi film, oggetti privati e di scena, lettere, documenti d’epoca che testimoniano le luci della ribalta che hanno illuminato il mito. Tutto questo per una mostra su Vittorio De Sica, grande regista e grandissimo attore, allestita a cura del Comune di Roma e della Cineteca di Bologna, a l’Ara Pacis, dall’8 febbraio al 28 aprile.
Era nato a Frosinone il 7 luglio 1901 da padre sardo e madre romana, ma diceva che nu cafone ‘e fora – come lui si definiva – può amare Napoli più di un napoletano e più volte pensò di prendere casa a Posillipo.
Come regista e attore, ironico e realista, sorridente e amaro, è stato tra i cineasti italiani più grandi del ‘900: uno dei patriarchi del neoreolismo.
Si trasferì in tenera età a Napoli con la famiglia, tutt’altro che benestante, anzi di “tragica e aristocratica povertà”, secondo la sua stessa definizione. Quando divenne famoso, favoleggiò sugli anni dell’infanzia e attribuì l’esordio da cantante a un’epidemia di colera. Era il 1911, le autorità proibirono perfino di mangiare i fichi, ma la madre non esitò a procurarsene, perché costavano poco. Durante gli acquisti dagli ambulanti, il piccolo Vittorio fungeva da palo per dare l’allarme all’arrivo della legge. Quando si profilarono due carabinieri, intonò Torna a Surriento. Ai militi piacque, “bravo, guagliò, vai avanti”. Interpretò tutto il repertorio napoletano a lui noto e i fichi furono salvi. Scoprì lo spettacolo dopo il diploma di ragioniere e un impiego alla Banca d’Italia, diviso con lo studio all’università. Cantò i classici napoletani, fece prosa. Forse era fin troppo moderno, per i gusti dell’epoca, e non fu capito subito. Ernesto Murolo lo bocciò: “Tene sulo nu filo ‘e voce”; e, alludendo alla sua magrezza, aggiunse: “Pare nu miezo tisico”. Lo apprezzò, invece, Enzo Lucio Murolo, l’inventore della sceneggiata. Si era quasi rassegnato a un destino da bancario, fu il padre a spingerlo allo spettacolo. Al cinema esordisce nel 1918, a 17 anni, rivestendo un ruolo secondario ne “Il processo Clemenceau” di Bencivenga, per comparire poi in altri film, dove mette a punto il personaggio di giovanotto brillante e scanzonato.
Il grande successo di pubblico lo raggiunge però solo nel 1932, quale protagonista di “Gli uomini, che mascalzoni!” di Mario Camerini. Successivamente, prosegue nella sua carriera divistica con pellicole di valore diseguale – delle quali vanno ricordate, sempre per la regia di Camerini, “Darò un milione” (1935), “Il signor Max” (1937) e “Grandi magazzini” (1939) – per debuttare infine dietro la macchina da presa con “Rose scarlatte” (1940), adattamento di un testo teatrale di successo. Dopo aver firmato alcune piacevoli commedie, muta registro con l’intenso “I bambini ci guardano'” (1943), che annuncia la leggendaria stagione del neorealismo e segna l’inizio della fortunata collaborazione con Cesare Zavattini: è da essa, infatti, che prenderanno le mosse “Sciuscià” (1946) e “Ladri di biciclette” (1948), entrambi premiati con l’Oscar ed entrati a far parte della storia del cinema mondiale. “Miracolo a Milano” (1951) ed “Umberto D.” (1952) consacrano la sua e ne segnano l’apogeo di autore.
Fra gli altri suoi film vanno ricordati poi, “L’oro di Napoli” (1954), “La ciociara” (1960), “Ieri, oggi, domani” (1963), “Il giardino dei Finzi Contini” (1970), gli ultimi due ancora premiati con l’Oscar.
Maestro del neorealismo e della commedia, venerato nel mondo intero, De Sica è presentato come non si era mai visto, come attore, autore ed uomo, con oggetti di culto (la bicicletta del suo film più celebre, la cassetta di quando, agli inizi della carriera, girava per i teatri italiani) e documenti personali, messi a disposizione dai figli Emi, Manuel e Christian, per rileggere la vita e l’arte di un grande innovatore.
Ciò che la mostra si propone è di superare la lettura riduttiva sul De Sica neorealista, per raccontare la figura di un grande e costante innovatore, nel cinema, così come nella vita, un uomo che non a caso e’ nell’occhio del ciclone tanto sul piano personale – non dimentichiamo la scomunica della Chiesa – quanto su quello professionale, con le continue vessazioni subite da una censura che non mandava giù le sue idee e le sue rappresentazioni di alcuni questioni chiave della cultura italiana. La rassegna ruoterà anche attorno al sodalizio artistico tra i più felici della storia del cinema: quello con Cesare Zavattini, conosciuto nel 1939, dalla cui penna sono nati Sciuscià, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano, fino a quell’Umberto D. che nel 1952 segnerà un anno di svolta per De Sica, con la reazione all’insuccesso (e alle aspre polemiche scaturite dal film) e la fuga, in un certo senso, del De Sica attore dai film da lui diretti per trovare altrove e con altri autori la sua migliore espressione (e da esempio per tutti valgano i ruoli in I gioielli di Madame De di Max Ophuels e in Il generale della Rovere di Roberto Rossellini.
Ma si racconteranno anche gli altri volti di de Sica, il cantante e l’uomo di avanspettacolo, ma anche il marito di mogli diverse ed altrettanto amate, Giuditta Rissone e Maria Mercader, ed il padre attento di tre figli egualmente adorati.
Stanco dell’ondeggiare fra due famiglie, tentò invano di ottenere il divorzio all’estero. Passò tre anni in Francia per ottenerne la cittadinanza e il 6 aprile 1968 finalmente sposò Maria, testimone Roberto Rossellini. Ma fu soltanto una cerimonia di affetto, senza effetti legali in Italia.
Il viaggio, del 1974, fu l’ultima prova cinematografica, protagonista l’amica Sofia. De Sica morì poco dopo in Francia per le conseguenze di un’operazione resa necessaria da una cisti a un polmone. I tre figli di due mogli si conobbero ai funerali e si abbracciarono. Non si sono lasciati più: perché Vittorio De Sica, doppio marito, fu comunque un ottimo padre. Vittorio De Sica era innamorato di Ischia e di Capri. Nelle isole del sogno girò film, passò periodi di spensieratezza. Gli ischitani non hanno dimenticato i suoi abiti immacolati, il suo panama, quando girò Vacanze a Ischia di Mario Camerini, accanto alla bella Myriam Bru, di cui il produttore Angelo Rizzoli era innamorato perso. I capresi non hanno dimenticato la sua eleganza e la ironia, sul set con Sofia Loren e in guizzi di villeggiatura.
Ma Ischia e Capri non avevano un casinò. Così De Sica elesse seconda patria il principato di Montecarlo, altro mare, ben diverse emozioni. Accettò perfino di girare un film – Montecarlo, appunto, del 1956 – in cui recitò il quasi autobiografico ruolo del conte Dino Giocondo della Fiaba. Incarnò un patrizio che aveva perso tutto alla roulette e cercava con squinternati amici il sistema di far saltare il banco.
Non solo per bisogno di guadagno, De Sica accettava ogni film il cui set era dalle parti di un casinò. Dopo aver perso, si congedava con classe, baciava la mano alle dame e lasciava persino una mancia al croupier. Ripeteva: “Il vero signore lo si vede al tavolo da gioco”. Lo disse anche ad Alberto Sord in Il conte Max: “Il vero giocatore deve essere freddo, impassibile, distaccato”. Nel 1963 ebbe il periodo più nero e se ne dolse scrivendo alla figlia Emi. Doveva pagare un debito al gioco di tre milioni e Dino De Laurentiis non gli aveva ancora pagato tre milioni di cachet. Concluse: “Farò, forse, una puntatina a Cava de’ Tirreni, dove c’è un circolo”. Il vero giocatore è un gran signore e vuola rifarsi. Aveva cominciato a giocare al tempo dei telefoni bianchi, si era fermato all’epoca del neorealismo, riprese negli anni Cinquanta, quando guadagnava anche un milione al giorno. In Il generale Della Rovere, Roberto Rossellini gli fece dire: “Sai qual è la fonte di tutti i miei guai? Il gioco. Perdo sempre”. Ma la partita dell’arte la vinse largamente.
Dalla mostra, divisa in tre parti, la prima sulla sua vita privata divisa, la seconda sul lavoro con gli attori, da Sofia Loren a Mastroianni senza dimenticare Sordi, la Lollobrigida e Totò e la terza illustra il regista), si intende far emergere la figura di un uomo innovativo, sia nel cinema sia nella vita, sempre al centro dell’attenzione in campo professionale come in quello privato.
Grazie alla mostra, ad esempio, si scopriranno gli stretti legami fra De Sica e la canzone napletana, un amore che lo o portò a incidere dischi (‘O mese d’ ‘e rrose, Munastiero ‘e Santa Chiara) e addirittura a partecipare a un Festival, in veste di paroliere. La sua Dimme che tuorne a mme!, musicata dal figlio Manuel, nel 1967 fu interpretata da Nunzio Gallo e da Luciano Tomei. Disse Dino Falconi, autore di riviste: “Nessuno meglio di me può assicurare che Vittorio De Sica cantava come soltanto un napoletano sa cantare”. Nella maturità, incise Signorinella di Bovio. Fece in tv un duetto con Mina in A marzo quando piove. Per la collana Raccolta o Recital dedicò album a Di Giacomo, Ernesto Murolo, Galdieri, in cui interpretava canzoni e recitava poesie. L’ultima incisione avvenne nel 1971: De Sica anni Trenta, realizzata con il figlio Manuel.
Ma la mostra sarà anche un modo, per i cinefili, di riflettere globalmente sulla grande stagione del Neorealiasmo e sui diversi contributi dei suoi grandi protagonisti, con Roberto Rossellini che preferì la lettura drammatica della società attraversata dalla guerra; Vittorio De Sica che mise in luce la solitudine e la povertà; Cesare Zavattini, che diede libero sfogo alla fantasia; Luchino Visconti che esaltò le grandi rappresentazioni, mentre Luigi Zampa si concentrò sui difetti e sulle disgrazie della gente comune e, infine, Pietro Germi, Alberto Lattuada e Giuseppe De Santis che ripresero, in forma cinematografica, la tradizione del romanzo italiano.
Vale qui la pena di ricordare che quella spinta rinnovatrice si esaurì nella sola esperienza artistica, in quanto non fu capita dalla maggioranza degli spettatori, che trascurarono questi film, preferendo quelli di genere leggero e, soprattutto, la produzione statunitense che ritornava in Italia, dopo la guerra. Film come Paisà, Sciuscià, Ladri di biciclette, Germania anno zero, Terra trema, Umberto D., passarono nell’indifferenza per almeno due motivi: il pubblico nei cinema cercava divertimento e rassicurazione e non voleva vedere le ristrettezze della vita quotidiana; il governo italiano non aiutò e favorì questo tipo di pellicole, temendo che l’immagine dell’Italia risultasse troppo negativa. Infatti, alcuni film furono prodotti da soggetti estranei all’ambiente cinematografico, come l’Associazione Nazionale Partigiani che sostenne le pellicole Giorni di gloria, Il sole sorge ancora, Caccia tragica; il Centro Cattolico Cinematografico che produsse i film Un giorno nella vita e Guerra alla guerra, mentre Luigi Zampa trovò in Sicilia il finanziamento privato per girare Anni difficili.
Sicché, il Neorealismo risultò più noto all’estero che in Italia, dove il pubblico premiò i film più rispondenti ad una certa tradizione ed in linea con la continuità del cinema d’evasione, che diede vita, negli anni cinquanta, al boom del genere comico (Totò, Macario, Rascel), del dramma sentimentale (Nazzari), delle opere liriche, delle ricostruzioni storiche, del film musicale (Carosello napoletanio di Giannini, del 1953).
In quegli anni maturano alcuni registi (Zampa, Lattuada, De Santis, Germi, Comencini, Steno, Monicelli) che, pur piegandosi alle esigenze di botteghino, non dimenticano l’esperienza maturata nel Neorealismo, tutto a vantaggio di una certa nitidezza espositiva e di certi temi sociali aggiornati.
Ed è da quella esperienza che sono venuti fuori i grandi autori del post-neorealismo: Fellini, Antonioni, Pasolini, Bertolucci, Bellocchio, Olmi, Rosi, i fratelli Taviani ed anche Sergio Leone.
Tornando a De Sica, più di altri ha portato concretamente al cinema la teoria di Deleuze, espressa nei volumi Cinema I e II, nata da una complessa tassonomia degli autori da Bergson e Pearce, secondo cui, nel passaggio da immagine-movimento hollywoodiano, fatto di azione-reazione, nessi logici e concatenazioni oggettive di vario tipo (pensiamo alle scene di inseguimento), il neorealismo è rivoluzionario in quanto istituisce l’immagine-tempo, fatta di divagazioni, reazioni mancate, allucinazioni, vagabondaggi senza meta, scomparse immotivate, attese continue – fino alla famosa definizione degli spazi qualunque, gli any-spaces-whatever della traduzione inglese che lo rendono cinema del veggente più che dell’attante.
Non a caso per Enrico Ghezzi, il quale afferma controcorrente e provocatoriamente, che il neorealismo non è mai esistito se non come uno iato nel tempo, sostiene che la vera affermazione cinematografica di tale schema che supera il senso motorio americano ed apre la via non solo alla Nouvelle Vogue, ma anche ad esempio al cinema di Cassavetes, si ha solo in due film: “Umberto D”, di De Sica e “Una questione privata”, tratta da Fenoglio, divenuto film nel lontano (dal neorealismo storico) nel 1991, con sceneggiatura di La Capria e regia di Alberto Negrin.
Da tempo accarezzo l’idea, come Istituto Cinematografico Lanterna Magica, di una rassegna intitolata “Le conseguenze del Neorealismo”, da far partire con il film di Negrin e proseguire con Cassavetes (Ombre, Blues di mezzanotte, Gli esclusi, Mariti) e ancora “I fucili degli alberi” di Jonas Mekas, Hallelujah the Hill di Jonas e Adolphas Mekas, THX1138 di George Lukas, Marcello I’m so Bored di John Milius, Buttati Bernardo di Coppola, Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno di Scorsese, per chiudere con Le conseguenze de l’amore di Sorrentino, regista neorealistico in senso pieno, per la sua attenzione al contemporaneo, descritto spesso in modo allusivo e metaforico, ma con uno stile incisivo, elegante, riflessivo, stimolante, profondo ed introspettivo, il cui scopo è di una presa di coscienza civica e politica in base alla quale avvedersi che i disastri morali ed economici di oggi sono simili, se non peggiori, di quelli che i nostri padri e i nostri nonni hanno dovuto affrontare nel secondo dopoguerra, frutto di cinismo e di disumanità, che vanno denunciati e, soprattutto, superati, smascherando una classe dirigente (politica, culturale, accademica, istituzionale) che senza ritegno alcuno ha condotto stili di vita all’insegna del consumismo più sfrenato, dell’abuso di ogni forma di agiatezza e dell’osservanza ossessiva dei “vizi capitali”: superbia, avarizia, lussuria, invidia, gola, ira e accidia.
Se è vero che è Scorsese il più grande cineasta vivente, capace di interrogarsi sulla possibilità di condurre un’esistenza cristiana in un mondo sostanzialmente dominato dal male e se è vero che tale cinema, tecnicamente, risente di Godard, Powell, Pressburger, Visconti, Rossellini, Ford, e Douglas Sirk, è altrettanto vero che i contenuti, capaci di narrare con particolari punti di vista le storie di uomini underground ed una prodigiosa, attenta direzione degli attori, deriva soprattutto da De Sica e da lui deriva anche il modulo centrale del cinema di Sorrentino e di Matteo Garrone, come sottolineato anche, lo scorso novembre, alla “Giornate professionali del cinema” di Sorrento.
La figlia Emi, nel 2004, in una rassegna sorrentina per celebrare i trent’anni dalla morte del padre, disse che la frase che più lo rappresenta è: “sono un attore drammatico, che per diletto canta canzoni”. Credo, avesse perfettamente ragione.
La melanconia nascosta da un vistoso buonumore da gigione, l’ha espressa soprattutto, credo, in un film minore del grande Luciamo Hemmer: “Il bigamo” (1954), vita di Mario De Santis, rappresentante di commercio, marito di Valeria e padre di un bambino, sconvolta dall’accusa di bigamia, che di fronte a tale situazione perde la testa, diventa aggressivo e finisce agli arresti. Commedia che ha nella parte processuale ha il suo vero punto di forza, con un De Sica davvero incontenibile come avvocato che difende il “bigamo” Matroianni.
Due dei suoi figli hanno seguito la carriera artistica: Manuel, musicista e scrittore, autore delle colonne sonore di molti film del padre e il più noto Crihstian, che ha all’attivo una grande quantità di pellicole tutte basate sullo stesso prototipo: il marito gattone e piacione, che corre dietro a tutte le sottane fuorché quelle della moglie.
Fra l’altro, da anni inseguito da voci circa una sua presunta omosessualità, smentita anche lo scorso ottobre quando gli si attribuì un prolungato flirt con l’attore Paolo Conticini, sua spalla comica negli ultimi 15 anni, tra cinema e spot televisivi.
Grande innamorato del canto e della danza, sin dagli esordi si è dedicato al mondo della canzone, partecipando nel 1973 anche a Sanremo e incidendo, nel 1994, un CD intitolato Solo tre parole.
Nel 2008 il figlio Brando lo dirige nel film Parlami di me, tratto da uno spettacolo teatrale scritto da Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime e presentato, ma senza grande consenso, al Festival di Roma.
Grazie a Pupi Avati ha invece avuto modo di sperimentare recentemente le proprie doti anche in ambito drammatico con Il figlio più piccolo,in cui il regista bolognese si cala per la prima volta nella realtà contemporanea per denunciare il vuoto morale che contraddistingue i potenti di casa nostra, a cui contrappone la forza e il valore dell’ingenuità e della speranza di chi crede nei propri sogni. E lo fa recuperando, appunto, un registro che Da Vittorio De Sica direttamente proviene.
(108)