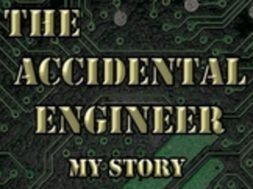(Di Carlo Di Stanislao) Inizia con una conferenza-intervista lunedì 10 dicembre, presso l’Hotel Quaianni de L’Aquila, un rapporto di collaborazione fra la sede aquilana del Panathlon International, organizzazione che persegue l’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali, quale mezzo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli e l’Istituto Cinematografica Lanterna Magica, da sempre inserito in ogni possibile iniziativa che veda il cinema come protagonista di crescita e di confronto etico e culturale. Fondato nel 1958, il Panathlon L’Aquila, presieduto da Fulvio Graziosi, ha di recente istituito, da assegnare alla squadra con il maggior comportamento rispettoso nei confronti degli avversari, il premio Fair Play, che andrà, a fine stagione, al team più corretto del girone B di Seconda Divisione di Lega Pro, dove milita L’Aquila Calcio.
Quanto al connubio con la Lanterna Magica, si intende promuovere, in forme diverse (proiezioni, rassegne, dibattiti), una corretta analisi del cosiddetto cinema sportivo, in cui lo spirito agonistico è metafora della forza e della determinazione necessarie per affrontare gli ostacoli della vita, con esempi numerosi e vari dedicati al calcio (Sognando Beckham, Fuga per la vittoria o il Maradona di Emir Kusturica); alla pallacanestro (Colpo vincente e Glory Road); al football americano, (Quella sporca ultima meta e Imbattibile), alla boxe (Lassù qualcuno mi ama o Toro scatenato, ecc.).
Oltre a discutere del fatto che, soprattutto Hollywood, ha generato un cinema sportivo più basato su valori individuali che generali, con esempi facilmente rintracciabili nel passato (All American Boys) e nel presente (Invictus) e poche, pochissime eccezioni (Momenti di gloria).
Inoltre la collaborazione permetterà, attraverso eventi successivi e di vario tipo, di definire il lungo rapporto fra il cinema e lo sport a partire dalla frase del grande teorico del cinema Béla Balász, che, a metà degli anni Venti, scrisse: “… e ci si è dati allo sport con sacro furore”, parole che, assieme agli elogi futuristi del film ginnico e dei temi dell’azione, del movimento, del gesto, spiegano meglio di ogni altra cosa il lungo e proficuo rapporto fra cinema e sport.
Il cinema nasce in un punto della storia moderna in cui lo sport ha già cominciato ad annullare quell’oblio del corpo che aveva avuto modo di consolidarsi nel corso dei secoli precedenti, nelle forme di una società basata sul primato della dimensione astratta e verbale a sua volta resa possibile dall’invenzione della stampa.
Ma, se tocca al cinema riscattare il patrimonio gestuale di una cultura che lo aveva dimenticato sotto il peso delle parole, è allo sport che spetta un compito di ‘apripista’ in tale processo. Si avanza per gradi: lo sport può rendere il corpo sano e bello; solo il cinema può donare una nuova eloquenza a tale bellezza.
Balász aiuta a descrivere l’incontro tra universo cinematografico e universo sportivo nel segno di una doppia nascita: una nuova cultura del corpo e una nuova cultura dell’immagine; fisicità e sguardo. L’attenzione per il dato visivo consegna l’uomo a una visibilità nuova che si realizza attraverso il cinematografo che, inteso come forma spettacolare, ha uno statuto, in relazione alle proprie potenzialità documentarie e riproduttive del reale e fa sfoggio della propria vocazione scientifica alla registrazione il più possibile analitica e oggettiva degli eventi e, al contempo, tradisce la propria derivazione da contesti spettacolari in cui il trucco, la messinscena, la ricerca della visione straordinaria sono ancora la reale posta in gioco.
Le prime tracce di incontro tra cinema e sport portano proprio di fronte a casi di ‘attualità ricostruite’. Pare infatti che sia stato un ex combattente della guerra di Secessione americana, Woodville Latham, ad avere per primo l’idea di fissare su pellicola il match tra due pugili dell’epoca, Michael Leonard e Jack Cushing. A Latham, sul finire dell’Ottocento, non viene neppure in mente di riprendere semplicemente un evento sportivo pre-esistente. Egli produce una messinscena pugilistica, in cui i due sportivi, scritturati come attori, sono coinvolti in un atto di rappresentazione, con tanto di interruzioni per consentire le riprese, le quali si svolgono in un teatro di posa newyorchese assai celebre, il Black Mary di Thomas Edison.
A consultare i cataloghi delle società di produzione dell’epoca è tutto uno scritturare atleti non professionisti, troupe acrobatiche, pugili, lottatori greco-romani, che a loro volta vengono affiancati da contorsionisti, cavallerizze, funamboli, tiratori scelti, ma anche da cani-lottatori, donne-cannone, giganti, e vari intrattenitori in continuità con le numerose forme di divertimento spettacolare disponibili alla riproduzione cinematografica: prove circensi, numeri di varietà, music-hall ecc.
Il primo esempio di una più stretta unione tra divismo sportivo e mondo dello spettacolo è con buone probabilità rappresentato dal caso di James J. Corbett, lo sportivo più famoso degli Stati Uniti; ex impiegato di banca, divenuto campione mondiale dei pesi medio-massimi e dei massimi nel 1892, rimasto imbattuto dal 1894 al 1897, che viene unanimemente ammirato per la sua correttezza agonistica e per l’eleganza nel gesto ed è inoltre il primo a introdurre l’uso dei guantoni.
E’ da questi prototipi che nasce il cinema dei ‘forzuti’, che si impone dagli anni Dieci del Novecento alla fine del decennio successivo come un fenomeno principalmente italiano. È attraverso questo tipo di narrazione ‘muscolare’ che si afferma il modello socio-iconografico del ‘corpo atletico’. Qui lo sport ha un ruolo non primario ma determinante. I forzuti sono uomini potentissimi, imbattibili che perseguitano i malvagi e annientano i nemici in virtù di una forza fisica a cui tutto deve soccombere, che si sprigiona e manifesta da corpi in grado di compiere azioni e gesti tipicamente sportivi. Il più celebre di essi è senz’altro il Maciste che compare per la prima volta in Cabiria di Giovanni Pastrone, nel 1914. Il nome è di derivazione dannunziana (un antico soprannome di Ercole) e ha bisogno di essere incarnato nel corpo di un semidio.
Mitico protagonista ed anzi eroe del tempo e del genere è Bartolomeo Pagano, trentacinquenne ex scaricatore del porto di Genova, che nel giro di pochi anni vedrà moltiplicarsi oltre alla popolarità anche i guadagni. Dal 1914 al 1928 Maciste spopola in una serie di film atletico-acrobatici che prevedono svariati ruoli: Pagano sarà imperatore, sceicco, alpino, poliziotto, medium, bersagliere; in un insieme di storie che tradiscono un’attrazione per i numeri spettacolari e le ascendenze dannunziane o superomistiche piuttosto che uno spirito di reale interesse nei confronti dei valori genuinamente sportivi.
Nel nome di questa sorta di culturismo voyeuristico vive sullo schermo un altro personaggio di derivazione letteraria, Tarzan; creato dallo scrittore Edgar Rice Burroughs nel 1912, interpretato da vari attori tra i quali il più celebre rimane il nuotatore Johnny Weissmüller che, dopo essere stato cinque volte campione olimpionico e aver raggiunto una cinquantina di record mondiali, ricopre il ruolo per la prima volta in Tarzan l’uomo scimmia (1932), a cui ne seguiranno seguiranno altri dieci, con al centro sempre il corpo atletico dell’attore-sportivo.
Un certo cambiamento ma nella continuità, con una visione al ritorno alla natura e alla magniloquenza costruttiva e narrativa, si ha con Olympia del 1938, di Leni Riefenstahl, in cui l’iconografia del corpo atletico trova sistematica (e ideologicamente compromessa) realizzazione sul piano del documentario delle Olimpiadi berlinesi del 1936.
Un film ideologico e per certi versi kitch, ma di non trascurabile portata, che mescola alla celebrazione della bellezza fisica intesa come prodotto di un confronto tra natura e artificio, come lavoro sul corpo educato armoniosamente allo sport; con le insidie tecnico-logistiche, rappresentate senza lasciarsi intimidire dalle difficoltà e riuscendo a fotogenici sport tutt’altro che tali: ciclismo, calcio, canottaggio, mediante l’impiego di risorse da vero kolossal e di espedienti tecnici di prim’ordine, il tutto al servizio di un racconto che da un lato ricostruisce, documenta certe competizioni (la maratona del nipponico Son, le imprese dell’americano Jesse Owens), dall’altro celebra la forza, la competitività, il mito della forma e della bellezza come varianti di una valorizzazione germanica del mondo.
Poi, nel mesto dopoguerra, con una società che cambia velocemente, gli abitanti dei grandi centri urbani vanno incontro a una modificazione rapida e progressiva dei propri tempi di reazione agli stimoli offerti dalla rutilante realtà esterna e lo shock percettivo ‒ di cui parla Walter Benjamin nel celebre saggio sull”opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica’ (1936) ‒ viene presto sostituito da forme di confidenza con spostamenti in bicicletta, automobile, treno ecc. Le masse guardano con ammirazione alle imprese degli aviatori e si inseriscono sempre meno passivamente nel mondo dell’attività sportiva.
Questa allora, diviene tema per l’attore comico, divenendo un aspetto specifico di un fenomeno generale riguardante l’aumento del dinamismo fisico nella società di massa. La gag sportiva si basa quasi sempre sullo scarto che intercorre tra il desiderio del performer di adeguarsi agli standard tecnici di esecuzione richiesti dalla disciplina e la sua reale competenza in materia, con un corpo comico Il che diviene corpo residuale, che non basta mai a sé stesso, che ‘manca’ l’azione; è in eccesso, troppo grasso o troppo magro e l’abilità atletica non è assente, ma semplicemente dissimulata. Non a caso il genere comico-acrobatico si afferma con personalità di provenienza teatrale e circense: André Deed (conosciuto come Cretinetti), Larry Semon (Ridolini), Max Linder, Robinet, Buster Keaton e Charlie Chaplin.
Jacques Tati era un valido calciatore, ottimo pugile dilettante, praticava il rugby e l’equitazione. Tali passioni si riversano ancor prima che sullo schermo in vari numeri di pantomima ispirati agli ambienti delle palestre e dei circoli sportivi poi eseguiti sui palcoscenici dei music-hall, al Ritz e al Tabarin. Dopo la prima fase di avvicinamento al cinema, che produce tra le altre cose un incontro con la boxe in Soigne ton gauche (1936), i film più celebri rimangono Giorno di festa (1949) e Le vacanze del signor Hulot (1953). Nel primo Tati fa un uso spericolato della bicicletta, mentre nel secondo trionfa in un torneo di tennis grazie a un indimenticabile servizio in tre tempi.
Anche Jerry Lewis incontra lo sport in Quel fenomeno di mio figlio (1951), in cui ha il ruolo del figlio ventenne di un celebre giocatore di rugby che non riuscirebbe mai a eguagliare le gesta del padre se non ci fosse l’amico, interpretato da Dean Martin, a incoraggiarlo e sostenerlo.
Oltre a ciò, coinvolgento il più possibile le scuole ed io giovani adolescenti in formazione, la collaborazione fra Panthlon e Istituto Lanterna magica, si farà anche carico di mostrare come, anche se è la boxe lo sport che tradizionalmente ha intrattenuto un rapporto privilegiato con il cinema, questo si è occupato (e spesso bene) anche di altro.
Anzitutto il golf, con i campi che sembrano luoghi adatti a ospitare un tipo di competitività incentrata sul piano del rapporto tra il giocatore e la sua meta (la buca) e in cui, molto spesso, al confronto con la sfida del tiro perfetto si affiancano elementi spettacolari estranei al genere sportivo e più che altro derivati dal territorio della commedia. È ciò che accade in due film che declinano la parabola sportiva seguendo i medesimi spunti: Lui e lei (1952) di George Cukor, in cui Katharine Hepburn, che gioca meravigliosamente a golf ma non riesce a fare neppure una buca se qualcuno la guarda, viene aiutata da un burbero Spencer Tracy; e Tin cup (1996) di Ron Shelton (un vero specialista del film sportivo), dove Kevin Coster, tra toni da sophisticated comedy, deve accettare lezioni di fiducia in sé stesso da una allieva-psicologa per poter diventare il campione che potenzialmente è.
Poi il basket, spesso associato alla realtà a lui più vicina, quella del campus universitario, come accade in come In punta di piedi (1960) di Joshua Logan o 40.000 dollari per non morire (1974) di Karel Reisz; ma anche in produzioni più recenti in cui lo sport è molto presente a livello quantitativo e sebbene non rappresenti affatto il fulcro della narrazione. È ciò che accade in He got game (1998) di Spike Lee, in cui, pur comparendo giocatori come Michael Jordan e Shaquille O’Neal, l’attenzione è spostata sul rapporto padre-figlio in un contesto di redenzione dai toni religiosi; e in O come Otello(2001) di Timothy Blake, tentativo non scorretto ma poco convincente di adattare all’agonismo sportivo la tragedia shakespeariana.
Ancora, naturalmente, il baseball, che si afferma in America molto rapidamente dalla fine della Guerra di Secessione (1861-65) e di cui il cinema registra la notorietà attraverso opere che presentano situazioni dedicate a tale sport pur restando fuori dal genere sportivo, o con contributi espressamente centrati su singoli protagonisti. Appartengono al primo gruppo Facciamo il tifo insieme (1948) di Busby Berkeley, con Frank Sinatra e Gene Kelly, in cui balli, canzoni e incontri si alternano con i ritmi della commedia musicale, e Che botte se incontri gli orsi! (1977) di Michael Ritchie con Walter Matthau e Tatum O’Neal. Appartengono al secondo gruppo due film diretti da Sam Wood: L’idolo delle folle (1942), dove Gary Cooper impersona Lou Gehring, giocatore morto prima della Seconda guerra mondiale, dopo sedici anni di onorata carriera; Il ritorno del campione (1949) in cui si narra la storia di un campione che, allontanato dai campi per la perdita di una gamba, grazie alla sua forza di volontà torna a giocare con un arto artificiale. Intorno al tema del ritiro forzato per ragioni di salute si sviluppa anche Batte il tamburo lentamente (1973) di John Hancoch, con De Niro. In questo caso al centro della storia sono due giocatori legati da un’amicizia virile che si consolida quando uno dei due si ammala. Senza calcare la mano sui toni melodrammatici, la regia riesce a restituire il clima di sconfitta in cui si svolge la trama con i problemi di rendimento e di reingaggio, di esclusione cui va incontro uno dei protagonisti.
Anche al rugby spetta nella storia novecentesca dello sport moderno un percorso di affermazione rispetto a quando Edoardo VIII d’Inghilterra lo aveva posto accanto ai reati comuni. Non pochi sono i film che prendono spunto da (o sono dedicati a) incontri di rugby. Tra questi si ricordano: L’atleta innamorato (1927) di Willard Webb, La grande sfida (1929) di John Ford, Partita d’amore (1932) di Sam Wood, l’italiano Stadio (1934) di Romolo Marcellini, Non per soldi…ma per denaro (1966) di Billy Wilder, Io sono un campione (1963) di Lindsay Anderson.
Anche gli sport acquatici trovano posto nel cinema, basti ricordare, ad esempio, Esther Williams, non certo attrice dalle grandi doti drammatiche, eppure personaggio di indubbia avvenenza fisica, protagonista assoluta nel sottogenere musicale coreografico con balletti in acqua.
E poi il surf, scoperto dal grande pubblico negli anni Sessanta, nel corso di tutto il decennio, compare come strumento inseparabile per dare sfogo alla voglia di emergere di una gioventù già inquieta ma non ancora ribelle, in tutta una serie non proprio indimenticabile di commedie da spiaggia. Da I cavalloni (1959) a L’onda lunga (1967) passa quasi un decennio in cui è collocabile uno dei capostipiti del film documentario sul surf: The endless summer (1966) interamente realizzato, tra California, Sudafrica, Hawai, da Bruce Brown; girato con una camera a mano posta sulla tavola o in immersione nell’acqua, mette in scena la ricerca dell’onda perfetta da parte di due surfisti. In chiave nostalgica è girato anche il documentario A personal history of the Australian surf, dove Michael Blakemore rivisita i luoghi della propria giovinezza collegandoli ad altrettanti momenti della propria attività sportiva. Straordinario il risultato ottenuto da John Milius in “Un mercoledì da leoni” (1978), dove i valori della vita e quelli dello sport si contrappongono di continuo e ciò che realmente conta, nell’oblio della realtà esterna alla spiaggia di Dark Point (fuori, di cose ne succedono: la storia è collocata tra il 1962 e il 1974, periodo ricco di avvenimenti politici ma diviso dai ritmi delle ‘grandi mareggiate’ interne al mondo del surf), è lo scontro tra il coraggio dell’individuo e gli elementi della natura, in questo caso messi in scena con una sontuosità di mezzi e con un’accuratezza di ripresa difficilmente eguagliate in seguito.
A sfidare Milius sul piano della resa figurativa, ha giocato alcune delle sue carte migliori Kathryn Bigelow con Point Break – Punto di rottura (1991) dove, sulle onde e attraverso una serie mozzafiato di prove di volo, di inseguimento e di forza, si confrontano un agente dell’FBI e una banda di ragazzi di spiaggia, beach boys ribelli che si autofinanziano rapinando banche.
Quanto al calcio, sport che ha contribuito più di qualunque altro a definire l’identità sportiva italiana e l’identità nazionale tout court, non ha mai trovato sullo schermo una messinscena che fosse in grado di renderne al meglio le peculiarità agonistiche. Prima della spettacolarizzazione diffusa dello sport in televisione, era abbastanza frequente la pratica del film di montaggio con materiali d’archivio sui grandi campioni. A questa categoria appartiene una serie di documentari che sono riusciti a mettere a fuoco la dimensione, altrimenti difficilmente registrabile, del protagonismo all’interno di uno sport di squadra. Tra questi: Goal! (1958) che ha al centro il trio brasiliano Pelè-Didi-Vavà, Idoli controluce (1966) che documenta le gesta di Omar Sivori, Libero (1973) in cui si analizza la figura di Franz Beckenbauer, Il profeta del goal (1976) dove la voce di Sandro Ciotti ripercorre la carriera dell’olandese Joahn Cruiff. Sul terreno del cinema di fiction il calcio funziona come pretesto per raccontare storie sviluppate all’interno di vari generi. In Parigi è sempre Parigi (1951) Luciano Emmer, dopo Domenica d’agosto (1950), continua a descrivere i desideri e i sogni della piccola borghesia narrando la trasferta francese di alcuni italiani al seguito della nazionale. Mario Camerini, in Gli eroi della domenica (1952), utilizza Raf Vallone, ex giocatore del Torino, per portare in scena un giocatore corruttibile in una squadra che ha la possibilità di passare in serie A. In L’inafferrabile 12 (1950) di Mario Mattoli, Walter Chiari fa la parte di un portiere della Juventus con un gemello che scatenerà la commedia degli equivoci.
Diverso il caso dello sport invernale, a partire dall’alpinismo, che ha trovato, già dagli esordi del cinema, un valido mezzo di documentazione nel lavoro alla macchina da presa di alcuni coraggiosi rocciatori-operatori. Il film di montagna, Berg Film, in una prima fase, è praticato da sciatori, alpinisti professionisti che fanno anche i registi. Le esigenze primarie sono quelle di produrre un evento sportivo che deve essere documentato. Tra i pionieri delle riprese in alta quota bisogna ricordare Mario Piacenza, il quale, dopo avere scalato più volte il Cervino, ha dato prova di abilità tecniche notevoli nelle riprese (in gran parte disperse) di ascensioni nelle regioni alpine e himalayane. Nei primi quindici anni del secolo scorso anche in Francia si diffonde la moda dei film plein air, ben presto affiancata da una massiccia produzione di intrecci drammatici di ambientazione montana, in realtà del tutto estranei allo spirito sportivo.
Più di recente si è passati alla spettacolarizzazione dello sport alpino, con film come Gli spericolati (1969) di Michael Ritchie e Centesimo di secondo (1981) di Duccio Tessari, interamente regolati sui ritmi dell’action movie a base di arrampicate acrobatiche, come nel caso di Cliffhanger (1993) di Renny Harlin e alla ricostruzione della scalata del Cerro Torre proposta, senza risparmio di scene di pericolosa realizzazione, da Werner Herzog in Grido di pietra (1991).
Per quanto concerne l’atletica, da Il corridore di maratona (1933) a Il vincitore (1979), il motivo della sfida a sé stessi e alle proprie possibilità agonistiche è al centro di molti soggetti (e indirettamente anche di un thriller di successo come Il maratoneta, di John Schlesinger, 1976), sul tema. Al vincitore del pentathlon e del decathlon ai Giochi di Stoccolma del 1912 Michael Curtiz ha dedicato Pelle di rame (1952) con Burt Lancaster; ma la biografia di Jim Thorpe sullo schermo non tiene conto delle drammatiche conseguenze del ritiro della medaglia su questo campione pellerossa. Con Momenti di gloria (1981) di Hugh Hudson, il cinema sportivo ritorna dopo diversi anni alla conquista dell’Oscar (ne vince quattro). Protagonisti sono due podisti britannici che rappresentano il proprio paese nelle specialità dei 100 e dei 400 m alle Olimpiadi di Parigi del 1924. In tutta la storia i motivi ideali di riscatto e lealtà sportiva dominano dall’inizio alla fine in un film senza ombre, di sicuro impatto spettacolare (Hudson fa un uso assai ricercato del ralenti per dare maggiore enfasi alle gesta sportive). Assai più problematico è il rifiuto della vittoria da parte di uno scattista-fondista in Gioventù, amore e rabbia (1962) di Tony Richardson, film fondamentale del Free cinema inglese nel quale le sperimentazioni formali sul tempo della narrazione si legano in modo assai efficace al rifiuto della gloria da parte di un marginale rinchiuso in un riformatorio.
Per concludere (questa lungo excursus sui temi che Panathlon e Lanterna Magica intendono sviluppare soprattutto, ma non solo, in ambito scolastico e formativo, il fatto, inequivocabile, che oggi il cinema deve rincorrere la televisione, come ha capito Oliver Stone, in Ogni maledetta domenica, con un film messo in scena seguendo la retorica da videoclip delle sintesi sportive.
(194)