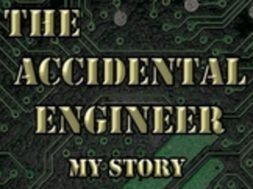Un esperto di cinema sosteneva che la fascia di pubblico che manca nelle sale cinematografiche è quella tra i 14 e i 20 anni. Questi spettatori, secondo lui, sono quelli che decretano il successo dei film di Checco Zalone o dei “Soliti Idioti” o di “Twilight” e che, di contro, non vanno a vedere altri film più impegnativi. Ma il problema, io credo, sia anche distributivo. Molte volte è accaduto che un prodotto mediocre abbia avuto un grande successo, a seguito di organizzate operazioni di marketing, comprendenti il merchandising, il lancio pubblicitario e la stessa confezione, ovvero come il film viene presentato, per mezzo di trailer azzeccati. Inoltre c’è anche il problema aggiuntivo della visione in streaming e sull’iPod, perché i giovani non sopportano il purgatorio che precede ogni film, fatto di oltre mezz’ora di pubblicità, trailer, annunci, spot e messaggi più o meno subliminali di locali notturni o pasticcerie. Inoltre, molte sale sono state costruite frettolosamente e con pochi soldi, anche se, dopo Guerre stellari, George Lucas aveva dimostrato che un fìlm commerciale, sostenuto da una forte campagna pubblicitaria in tv, poteva uscire simultaneamente in tutto il paese e attirare enormi folle di spettatori, già nel primo weekend. Scrive David Dalby, uno dei maggiori esperti contemporanei, che al momento gli investimenti più intelligenti si fanno sui budget pccolli, con imprenditori che hanno cominciato a fare affari non con gli studio, ma con i produttori di successo come Joel Silver e con i registi-produttori come Ivan Reitman. I soldi sono destinati a film di genere – thriller, commedie e horror – che rientrano nella categoria dei piccoli budget (circa venti milioni di dollari) ed alcuni diventano “eventi irripetibili”, con investimenti così relativamente piccoli da permetteere ai produttori di usare sceneggiatori e registi pronti a osare qualcosa di più, proprio come facevano sessant’anni fa i registi di serie B, faticando in silenzio e nell’ombra (si pensa, ad esempi a Roger Corman). Ma i film fatti in fretta e con pochi soldi avranno sempre bisogno dei grandi studios per la distribuzione e il marketing, anche se con la completa affermazione del digitale non sarà più così. E siccome la distribuzione è la chiave per la libertà, in futuro produttori, registi e sceneggiatori si liberereranno degli studios, formando delle cooperative capaci di pagarsi una distribuzione e una promozione che faccia arrivare i film direttamente nelle sale. L’anno cinematografico appena trascorso sarà ricordato per “Il cigno nero”, “Il discorso del re”, “Faust”, “The Artist”, “Drive”, “Super 8”, “Melancholia”, “Una separazione”, “Carnage”, “ A Dangerous Method”, “Midnight Paris”, e, passando al nostro di cinema, “Terraferma”, “Noi credevamo” e “Habemus papam”. Ma altri eccellenti film sono passati a volo d’uccello sugli schemi, con una distribuzione così scarsa da essere quasi inosservati. Ne vogliamo ricordare tre. In primo luogo il melanconico capolavoro di Gus Van Sant, il geniale regista di Paranoid Park, Elephant, Milk e Will Hunting, “Restless – L’amore che resta”, dolce, struggente, nostalgica storia d’amore tra due anime perse, che si trovano per accompagnarsi lungo un tratto della propria vita: quella di lei, che ha imparato a sorridere alla vita nonostante l’imminenza della morte, quella di lui, che la fugge, trascorrendola in compagnia di un improbabile amico immaginario, un giovane kamikaze giapponese, che altro non è se non il simbolo dell’accettazione della caducità della’esistenza. Una storia romantica e complicata, racchiusa in un film difficile, in cui a rappresentare la malinconica dolcezza di due giovani anime perse, contribuiscono le tonalità cromatiche dei colori e delle luci: i due personaggi, spesso agghindati con bizzarri, quanto assurdi abiti anni cinquanta, vivono la propria storia in un eterno autunno. E come le foglie, che restano pervicacemente attaccate al proprio ramo, così Annabel ed Enoch (i due protagonisti) attraversano il tramonto della propria vita rimanendo abbracciati l’uno all’altra. In attesa che arrivi l’inverno. Accolto con toni entusiastici all’ultimo Festival di Cannes – dove ha aperto la sezione Un Certain Regard Restless – L’amore che resta”, non ha goduto della stessa fortuna nel nostro Paese, dove la scarsa eco promozionale e la circolazione in un numero ridicolo di copieha tarpato le ali ad un’opera che segna il ritorno del regista, dopo la fortunata parentesi di Milk (otto candidature, due premi Oscar), ad alcuni tra i temi più cari della sua filmografia. La triangolazione amore-adolescenza-morte (presente, in nuce, già in Belli e Dannati) si libera delle atmosfere torbidamente angoscianti di Elephant e Paranoid Park – lavori, con Last Days, tra i più sperimentali e riusciti di Van Sant – pur senza abbandonarne il minimalismo strutturale, per caricarsi invece di una delicatezza nuova, non meno orientata alla decostruzione dei valori tipicamente stereotipati del genere lacrimevol-sentimentale hollywoodiano. La buona sceneggiatura dell’esordiente Jason Lew – molto efficace nella prima parte del film ma meno incisiva nella seconda – si rifà apertamente allo stra-cult di Hal Ashby Harold e Maude, costruendo il personaggio di Enoch sulla base di quello interpretato nel ’71 da Bud Cort (e con una spruzzata, sempre attuale, di Holden Caulfield salingeriano). Come Harold Chasen anche Enoch Brae è un adolescente dal guardaroba antiquato (qui riletto in senso eclettico e vintage dal costumista Danny Glicker) e dai modi stravaganti, il cui morboso interesse per la morte – meno fantasioso e comico di quello sperimentato da Harold (i cui teatrali tentativi di suicidio restano indimenticabili) – tradisce il disagio di un trauma più profondo del “semplice” male di vivere. Autore abituato a correre sul doppio binario della normalizzazione mainstream (entro cui si collocano film come Will Hunting – Genio Ribelle, Scoprendo Forrester e lo stesso Milk) e della sperimentazione indipendente (è il caso di Gerry e della “trilogia minimalista” Elephant-Last Days-Paranoid Park), il regista di Louisville sceglie di affidarsi, con Restless – la traduzione italiana è, al solito, indifendibile oltre che inutile – agli stilemi di un’estetica che di indie ha soltanto i propositi espressivi ma non certo le basi “ideologiche” (il film, prodotto da Columbia Pictures e distribuito dalla Sony, è praticamente in mano alle majors, per quanto Van Sant possa permettersi di fare quello che vuole). La complicità dei due interpreti – l’ottima Mia Wasikowska (nel suo carnet, finora, solo progetti azzeccati) e l’esordiente Henry Hopper (per cui si prospetta una promettente carriera) – è il valore aggiunto indispensabile per donare leggerezza e credibilità ad una storia che avrebbe tutte le carte in regola per sprofondare nella melassa del sentimentalismo più convenzionale. Il primo innamoramento, la scoperta del sesso, le difficoltà di una relazione compromessa dalla precarietà del tempo – tutti temi sui quali riuscire a dire qualcosa di nuovo è impresa persa in partenza – godono allora di un trattamento speciale, grazie al quale la noia del già visto viene estromessa dallo schermo per fare posto alla possibilità di emozionarsi ancora. Come seconda pellicola 2011 da (ri)vedere, la splendida commedia di Shari Springer Berman, e Robert Pulcini (moglie e marito), “Un perfetto gentiluomo”, con protagonista tale Louis Ives, un giovane insegnante di letteratura, che ha appena perso il suo posto di lavoro e che decide di trasferirsi a Manhattan, dove trova un impiego presso la redazione di una rivista ecologista. Nel frattempo il ragazzo si reca a vivere nell’appartamento di Henry Harrison, un drammaturgo dai modi bizzarri che sbarca il lunario facendo da accompagnatore a facoltose signore anziane. Trasposizione cinematografica del romanzo di Jonathan Ames “Io e Henry”, “Un perfetto gentiluomo” è un film che, nonostante la presenza nel cast di un attore quale Kevin Kline, è passato totalmente inosservato presso il pubblico, nonostante l’eccellente impegno basato su comicità surreale, è incentrata su due personaggi stravaganti e disadattati. Presentato al Sundance Film Festival, la pellicola ha riscosso un successo di critica notevole, uno dei più originali percorsi di formazione messi in scena in questi ultimi anni, l’incontro tra il giovane sfigato e il mentore burbero ma dal cuore d’oro, diventa la storia di un’amicizia atipica tra due personaggi che non hanno nulla da insegnarsi ma tutto da condividere, confessarsi, rendendo partecipe l’altro della propria vita senza però aspettarsi la soluzione per diventare uno scrittore migliore, un fidanzato migliore, un amante migliore, un uomo migliore. Molto del merito va alla straordinaria performance di Kevin Kline, uno dei pochissimi attori in grado di interpretare un personaggio simpatico ed arrogante al contempo, che ricorda a più riprese l’Otto di Un pesce di nome Wanda. La degna spalla di Kline è un bravo Paul Dano, mentre in ruoli secondari compaiono Katie Holmes e un irresistibile John C. Reilly, barbuto e con voce in falsetto. L’ultimo titolo è un docu-film ed in più italiano: “Pasta nera”, firmato dal giovane e talentuoso Alessandro Piva, storia che racconta, tra il 1945 e il 1952, dei più dei 70.000 bambini del Sud più svantaggiato, che furono ospitati temporaneamente da famiglie del Centro-Nord e che presero così il primo treno della loro vita, per lasciarsi alle spalle la povertà e le macerie del dopoguerra e vivere un’esperienza che non avrebbero mai più dimenticato. “Pasta Nera” riporta alla luce uno dei migliori esempi di solidarietà e spirito unitario nella storia del nostro Paese, ma lo fa senza retorica e con una narrazione sempre interessante. Protagoniste indiscusse dell’enorme macchina organizzativa, attraverso l’Unione Donne Italiane, e i comitati organizzati in ogni città, furono le donne, che riuscirono, tra mille difficoltà a portare quei bambini, laceri e denutriti, in un contesto di dignità e di riscatto. I protagonisti di questa storia, ormai nonni, ricordano con i loro occhi di bambini questa esperienza inedita, creando un cortocircuito emozionale tra infanzia e anzianità e dicendoci, a noi italiani di oggi, che è la solidarietà un valore primario per una Nazione che intenda progredire. Nato a Salerno nel 1966, diplomato in montaggio nel ’90, presso Il Centro Sperimentale di Cinematografia, Alessandro Piva, svolge la sua attività spaziando tra cinema e televisione, radio e teatro e forte impegno politico e sociale, come l’iniziativa Perotti Point, legata all’abbattimento dell’ecomostro Punta Perotti sul lungomare di Bari, che ha portato in Puglia filmaker di tutta Italia, per costruire un documentario collettivo sull’evento. Nel 2010, a conclusione del 28° Torino Film Festival, il suo terzo lungometraggio, “Henry”, ha vinto il premio del pubblico per il Miglior Film. La sua opera prima, del 2003, “La CapaGira”, è stata presentata al festival di Berlino e gli ha permesso, lo stesso anno, di ricevere , come miglior regista esordiente dell’anno, i relativi premi dai due maggiori riconoscimenti eventi cinematografici italiani: David di Donatello e Nastri d’argento. Questi tre film (ed altri di cui ora ci è possibile parlare, come “Warrior” di G. O’Connor, “The Tree Of Life di Malick, “Il pezzo mancante” di G. Piperno, “Il ragazzo con la bicicletta” di J.L. e P. Dardenne e “Monsters” di G. Edwards, “Super” di J. Gunn, “Bad Teacher” di J. Kasdan, “Rango” di G. Verbinski), sono da raccomandare caldamente ai curatori del Missing Film Festival – Lo schermo perduto, progetto speciale promosso dai CGS Cinecircoli Giovanili Socioculturali e organizzato dal Club Amici del Cinema, che da 20 anni offre al pubblico genovese un programma fitto di film premiati in molti festival, ma non sempre sufficientemente apprezzati nelle sale. Vedremo se a novembre prossimo questi titoli (o alcuni, almeno), saranno rintracciati, per la XXI edizione del ghiotto festival genovese. Ma torniamo per un istante ai ragazzi (cui tengo molto come presidente di una istituzione- La Lanterna Magica de L’Aquila- che della formazione dei giovani al cinema ha fatto un “must”), ai ragazzi che vengono spinti a guardare i film su un lettore portatile e che si dovranno accontentare di un’esperienza incompleta, anche se non lo hanno mai saputo e mai lo sapranno. La loro scelta di consumo potrà influire su tutti gli altri, proprio com’è successo nel business della musica. Insomma, il futuro del cinema come forma d’arte è in pericolo, se non riusciamo a riportare questi giovani al cinema e con capacità critica e di giudizio. Negli anni cinquanta, in un periodo in cui il controllo degli studios si era allentato, si sviluppò un’altra struttura produttiva, grazie a cui registi come Nicholas Ray, Anthony Mann e Douglas Sirk realizzarono lavori decisamente impegnativi. Nei primi anni settanta s’impose invece il modello produttivo che rafforzava il controllo da parte del regista. I produttori, presi in contropiede dai gusti delle nuove generazioni, si rivolsero a giovani diplomati delle scuole di cinema come Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg e Robert Altman (che era però di una generazione più vecchio). Lavorando in piena libertà, questi registi tirarono fuori una serie di film eccezionali con protagonisti dal carattere sfaccettato e dalle fisionomie sorprendentemente originali. Il sistema attuale dei grandi studios, invece, non solo svilisce l’aspetto artistico, ma è anche irrazionale dal punto di vista finanziario. Ed allora è questo sistema da cambiare, oltre al gusto delle giovani generazioni. Bisogna, insomma, che cambi il sistema per cui, quando un film comincia a guadagnare, i premi sono divisi secondo proporzioni prestabilite. Alla casa cinematografica e ai suoi partner finanziari che hanno messo in piedi il budget di produzione spetta la fetta più grande, per esempio il 50-60 per cento. Una star prende il 6 per cento, un’altra star 5, lo sceneggiatore 2, e così via. Se il film è un flop, gli incassi di tv e dvd serviranno ad attutire le perdite, cosa che fanno normalmente. Se il film è un successo, tutti avranno una fetta della torta. In questo modello economico c’è un risvolto positivo anche dal punto di vista artistico che aiuta a superare la paura del rischio. “Se la spesa iniziale è contenuta”, spiega Soderbergh, “ci sono buone possibilità che in futuro gli studios facciano delle scelte più coraggiose”. Ma occorrerà, a quel punto, avere un pubblico, soprattutto giovane, capace di apprezzarle.
Carlo Di Stanislao
(40)