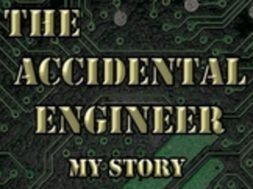(di Carlo Di Stanislao) – Quella di Venezia 2012 è una mostra al femminile, con tre quarti dei registi, nelle varie sezioni, che sono donne. E questo ci fa un enorme piacere, sia perché lo sguardo è più fresco, sia perché il punto di vista è differente.
Forse il motivo vero è che gli organizzatori, con gli occhi di tutti puntati addosso, non volevano incorrere in quanto accaduto a Cannes lo scorso maggio, con un gruppo di attrici e registe che scrisse una lettera aperta a Le Monde, criticando l’assenza di autrici tra i 22 finalisti in corsa per la Palma d’oro; lettera molto aspra, dove, fra l’altro, si leggeva una cosa piuttosto vera: “gli uomini amano le donne per la loro profondità, ma solo quando hanno una scollatura profonda”.
Di fatto, a guardare la storia del grande festival francese, con un’unica donna ad aver vinto la Palma d’oro (Jane Campion, nel 1993, con “The piano”), il sospetto di maschilismo appare piuttosto giustificato.
E la situazione è appena meno grave per Venezia, con due premi, a Mira Nair per Monsoon Wedding (2001, ultima della prima fase Barrera) e, poi, fra l’altro con un film discutibile e con la vistosa complicità, dell’ex-fidanzato Tarantino, a Sofia Coppola, per Somewhere, lo scorso anno (l’ultimo, del regno Muller).
Barrera, tornato in sella dopo 11 anni, ha voluto rimediare. Ed ecco allora una nutritissima compagine femminile ed una maggiore apertura al complicato ruolo delle donne nella società.
Ma, curiosamente, il vero simbolo di questa “infiltrazione”, almeno a me pare, sta in un film maschile: The Iceman; noir di Ariel Vromen, basato sulla vera storia del killer della mafia Richard Kuklinski, con Winona Ryder nel ruolo della moglie, che da vita ad un personaggio in cui si trasferiscono le complessità di un universo (quello di Eva) che si divide fra luci e ombre, convenzionalità e suo superamento, con infinite sfumature di colore e innumerevoli varianti di grigio.
Ruolo ambiguo, ignaro ed insieme consapevole, come ambigua è la femminilità in crescita e cambiamento in questi anni.
Israeliano di nascita, con all’attivo l’eccellente “Rx” (2005), Vromen realizza un doppio spaccato sulla dualità: una più evidente (quella del killer, spietato esecutore e, insieme, padre esemplare e perfetto borghese); l’altra più complessa e ramificata (la moglie), grazie alla straordinarie doti della Ryder.
Le stesse che facevano emergere una femminilità che ancora soffre, fra dubbi e consapevolezze, ne “Il cigno nero” e in “Dilemma” di Ron Howard e che, nelle note più tipiche e singolari di questa straordinaria attrice, l’hanno fata scegliere, ancora una volta, da Tim Burton (suo mèntore in Beetlejuice – Spiritello Porcello e Edward Mani di Forbice), per dare voce ad uno dei personaggi più doppi ed ambigui di Frankenweenie, sua prossima fatica in stop-motion.
Ritornata sulle scene dopo l’arresto per cleptomania, nel 2002, la Ryder ha subito recitato in modo incredibile in due ruoli complessi: A Scanner Darkly – Un oscuro scrutare, presentato a Cannes e in The Darwin Awards – Suicidi accidentali per menti poco evolute, successo al Sundance Film Festival; mettendo in campo la stessa ambiguità, fatta di cielo e inferno, ingenuità e pragmatismo, che l’avevano resa immortale in film come Dracula di Bram Stoker e L’età dell’innocenza.
A Venezia, in conferenza stampa, con abito nero al ginocchio e coda di cavallo, la Ryder, con il suo sguardo magnetico e l’eterna espressione da adolescente, ha detto una cosa che riguarda molte donne di oggi.
“Sono entrata in una fase in cui la cosa che più voglio è vivere: avere una bella, una buona vita. Il lavoro per il lavoro non mi interessa più. E così solo se c’è una pellicola, una storia talmente avvincente da distogliermi da questa mia vita, mi ci butto: come in questo caso, appunto. Grazie a un ruolo del tutto diverso da quelli a cui sono abituata, che mi ha costretto a mettermi in discussione e a cercare un approccio differente. Giocando tutto sull’ambiguità del personaggio: un concetto che noi attori conosciamo bene, visto che il nostro mestiere è fingere di essere qualcun altro”.
Coraggio e voglia di novità, di respiro, di sfida e di fantasia: tutto quello che pare mancare, oggi, a noi uomini, arrabbiati e messi in un angolo.
E, soprattutto, una giusta collocazione dei valori, umani e professionali, frutto di una maturazione dolorosa, con il successo raggiunto da ragazzina, la fama planetaria, lo status di superstar e, poi, le disavventure legate alla cleptomania, l’appannamento della carriera, il rischio del viale del tramonto.
Il 2001, l’anno della sua capitolazione, l’anno in cui fu sorpresa a rubare in un grande magazzino di Beverly Hills e che sembrò significare la sua personale “Torri Gemelle”, appare lontano anni luce.
Ancora più sfuocata sembra la relazione con Johnny Depp, che si fece tatuare “Winona Ryder”, poi convertito in “Wino Forever”, “Vino per Sempre”, dopo la burrascosa rottura.
Ma mentre Depp è rimasto avvinghiato ad uno stereotipo infantile di genio e sregolatezza; lei è cresciuta, come attrice e come essere umano, con l’aria mite e un po’ fragile, dietro cui conservrea una tangibile traccia di turbolenza e, soprattutto, una grande voglia di mettersi alla prova, senza paura o tentennamenti e per comprendersi (e accertarsi) fino in fondo.
Winona Laura Horowitz, la bambina nata nel Minnesota, in una piccola cittadina dalla quale ha preso il nome, trasferitasi, con i genitori, in una comune situata in un lotto di trecento acri vicino ad Elk, in California, dove non c’era la corrente elettrica, con Timothy Leary come padrino e Allen Ginsberg come amico; non è più la ragazzina attratta dalla morte di Beetlejuice, né la protagonista tormentata di Edward mani di forbice e neanche la donna con depressione e attacchi di panico di “Ragazze interrotte”.
Oggi è una donna consapevole dei suoi problemi, con molte risposte ma, soprattutto, con tante domande fondamentali, che dimostrano (come ha fatto sullo schermo in The Private Lives of Pippa Lee), che una è costretta, nella vita, a molti ruoli separati, come fossero molte vite diverse (moglie, madre, amante) e che resta un essere fragile, fragilissimo, finché basa tutta la sua realtà sugli uomini.
Ma che insieme possiede molte armi ed innumerevoli risorse, come lo spirito di avventura e la sensualità, capaci di farle vivere, in ogni istante, una vita contraddittoria, ma anche piena.
Non è un caso, credo, che il suo complesso io sia stato messo in totale evidenza in quella biopsia sporca e nevrotica sull’America di oggi, che è stato, nel 2004, “Ingannevole è l’amore sopra ogni cosa”, diretto da un’altra donna “liberata”: Asia Argento e tratto dal romanzo, molto femminile, di J.T. Leroy.
E’ in questo film, più che altrove, che l’accoppiata Argento-Ryder, sembra dire alle altre che liberarsi non è una colpa e, anzi, bisogna liberarsi ancora di più, per liberare tutti.
Uno schiaffo per chi si sente vittima di un orgoglio maschile distrutto ed in cerca di nuove identificazioni, un modello che potrà non esaltare, ma che ha l’ingrato compito di introdurre un bel bisturi dentro la pancia di un una virilità che, ipocrita com’è, non vorrebbe mai vedere come sono fatti i suoi nervi, le fibre, i muscoli e il midollo spinale, tutti ormai purulenti.
Da sempre sono (in realtà siamo, io e gli altri dell’Istituto Lanterna Magica de L’Aquila), interessati al cinema femminile, protagonista, ad esempio, della nostra rassegna di fine estate-inizio d’autunno “Frammenti di donna”.
Ed il nostro interesse è tale (e crescente) che, nonostante le scarse risorse, stiamo cercando di stabilire accordi con l’Associazione “Donne dell’Audiovision Promotion”, fondata nel 1996 da Cristina Zucchiatti e Donatella Senatore, coadiuvate da Paola Poli, che da anni cura, alla Casa del Cinema di Roma, il premio “Afrodite”, dedicato all’universo femminile nell’ambito dello spettacolo, in particolare cinema, fiction e creatività artistica, con rassegne sempre di grande interesse.
Premiate quest’anno (a luglio, in una serata condotta da Laura Delli Colli, presidente della giuria 2012), le attrici Laura Morante, Basrbara Bubulova, Antonia Liskova, Sarah Felberbaum e Francesca Inaudi e, come produttrice, Grazia Volpi, che ha esordito nel 1975, per la cooperativa Aata, con Quanto è bello lu morire accisu di Ennio Lorenzini, e poi prodotto Il sole anche di notte, Fiorile, Le affinità elettive e Tu ridi dei Taviani e, degli stessi, il capolavoro televisivo, in due puntate (2002) Resurrezione, dal romanzo di Leone Tolstoj e il recente (Orso D’Oro a Berlino) Cesare deve morire.
Speriamo di avere, nel prossimo anno, l’opportunità di ospitare lei ed alcune fra le premiate, in una rassegna dedicata al cinema femminile, a cui coinvolgere altri enti ed istituzioni, come, ad esempio, “Sguardi al Femminile”, ideata nel 2004 dall’associazione Culturale Mediterraneo, con le prime due edizioni tenute alla Stazione Termini, presso il mezzanino giallo e le successive due all’Università Roma Tre e “Lo schermo è donna”, della “Sezione Cinema Donne della Biblioteca di Genere”, che a giugno organizza da 15 anni, a Fiano Romano, una rassegna, in sei serate, dedicata alla settima arte, con le protagoniste delle ultime stagioni, tra giovani esordi e volti noti del panorama italiano.
Un evento in cui, però, dimostrare che, anche se raramente, gli uomini sanno parlare di donne, come accaduto con Truffaut e Almodovar o nel più recente “The Lady” di Luc Bresson ed intrecciate contributi come Quando la notte di Cristina Comencini, con Pina, grande omaggio di Wim Wenders a Pina Bausch; My Week with Marilyn di Simon Curtis con Franca, la prima, di Sabrina Guzzanti, sulla grande Franca Valeri; con “La passione di Laura”, omaggio complesso a Laura Betti, attrice, cantante, intellettuale e animatrice culturale, per anni direttrice del Fondo Pasolini, ruvida e scostante, da sempre in armi, con quell’inconfondibile timbro di voce, contro i pregiudizi, sempre controcorrente, che sosteneva (in tempi non sospetti): “Farei qualunque cosa mi venisse chiesta da un movimento femminile, tranne farne parte”, da parte del maschio Paolo Petrucci (con il quale ebbe un lungo sodalizio, artistico, oltre che umano); con La Brindille, di Emmanuelle Millet; Turn Me On, Goddammit!, dell’esordiente norvegese Jannicke Systad Jacobsen; con Girl Model, prodotto a quattro mani di David Redmon e Ashley Sabin; conButter, di Jim Field Smith.
Per poi chiudere con due cicche della nostra Cineteca de L’Aquila: Femmine folli del ’22 di Erich von Stroheim e Susanna di Howard Hawks del 1938, per mostrare come, in poco più di mezzo secolo, sia cambiato lo sguardo maschile sulle donne e come, per fortuna, siamo lontani, almeno, dalla feroce misoginia della donna-mostro di “Lola Montès”; “ Nella società degli uomini”; “L’angelo azzurro”, “L’ape regina – Una storia moderna” e “La donna scimmia”.
Una rassegna che mostri, in doppia versione femminile e maschile, che è bene guardarsi da uomini meschini, egoisti, squallidi, volgari e abietti, abili nell’arte del manipolare, ingannare, in una parola, fottere per il puro piacere di farlo, procurando inutili e gratuite sofferenze agli altri, che si giustificano affermando che questo è l’unico modo per difendersi dal nemico-donna.
Qualcosa che induca, soprattutto, a comprendere (come fa la Ryder a più riprese ed in vario modo), che se non si recupera il rispetto della differenza e dell’ascolto, saremo sempre più vittime, tutti, maschi e femmine, di una società arrivista e moralmente riprovevole, per lo più governata da relazioni fasulle e pericolose, ma soprattutto opprimente, con gretti, infimi ed annichilenti rapporti di forza e di potere (non solo tra uomini e donne, ma anche tra uomini), in cui nessuno è più un essere, ma solo un automa agitato dall’avere.
(100)